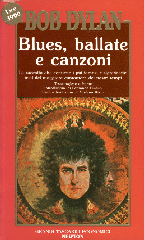MAGGIE'S FARM
SITO ITALIANO DI BOB DYLAN
MESSAGGIO
POETICO E COMUNICAZIONE DI MASSA NEL PRIMO BOB DYLAN
di Stefano Rizzo
MESSAGGIO POETICO E
COMUNICAZIONE DI MASSA NEL PRIMO BOB DYLAN
di Stefano Rizzo
Settembre 2003
Una diversa versione di questo saggio nasceva più di trent’anni fa, nel
1972, come introduzione (che poi non fu pubblicata preferendo l’editore –
e giustamente – pubblicare solo quella di Fernanda Pivano) a Blues,
ballate e canzoni, il libro che mi guadagnò una fama imperitura tra
diverse successive generazioni di giovani, nonostante le molte
manchevolezze della mia traduzione, solo perché fu il primo e (con il suo
compagno, Canzoni d’amore e di protesta) per molti anni l’unico libro di
traduzioni dei testi di Dylan. 1972. Un anno importante per me. In quello
stesso anno nasceva mia figlia, che passò i primi sei mesi della sua vita
ascoltando la voce raspante di Bob Dylan sui dischi che io, come un disc
jokey-rapper (che ancora non esistevano), facevo andare avanti e indietro
il piatto per tutta la notte cercando di decifrare il senso delle sue
parole (di Dylan, mia figlia non parlava, ma anzi si addormentava beata al
suono di Mister Tambourine Man, la sua canzone preferita).
Comunque, l’anno successivo, il 1973, presentai un’altra versione del
saggio, largamente ampliata e dotata delle note a pie’ di pagina richieste
dal contesto accademico, come tesi di laurea in filosofia all’università
di Roma, tesi che fu accettata grazie alla curiosità e all’intelligente
politica di apertura verso il nuovo del direttore dell’Istituto di
letteratura anglo-americana, Agostino Lombardo. Un’altra versione ancora
del saggio, con un’aggiunta e aggiornamento che lo portava al 1975, vide
la luce sul numero 302 di Paragone, la rivista di letteratura fondata da
Roberto Longhi, che forse si sarà rivoltato nella tomba, o forse no, ma le
responsabilità fu di Guido Fink. Infine qualche anno fa il gruppo degli
amici dylanologi napoletani del sito Maggie’s Farm, sempre dottissimi e
informatissimi, mi chiese notizie di quella mia antica tesi, che nessuno
aveva letto, certamente non loro che forse non erano nati quando già la
tesi dormiva sonni profondi negli archivi dell’Università. Gli promisi di
mandargliela, ma non mantenni la promessa.
Volevo riscrivere il saggio, dal momento che si fermava al 1973, erano
passati, come ho detto, trent’anni e certamente era ormai
irrimediabilmente datato, pensavo. Così lo rilessi e, con mio stupore, mi
resi conto che non era affatto invecchiato. Invece che con “1973. Sono
undici anni che Bob Dylan alias Robert Zimmerman...”, avrei potuto
incominciare con “2003. Sono quarantun anni che...” (Quarantun anni… sono
un sacco di tempo e già questo sarebbe prova di grande vitalità, ma a
pensarci bene quanti sono i mostri – come li chiamò Fernanda Pivano –
della canzone americana che sono ancora sulla scena?) Avrei potuto
raccontare molte cose, dire che in tutti questi anni Dylan ha scritto
centinaia di nuove canzoni, che ha fatto migliaia (forse decine di
migliaia) di concerti, sempre fedele alla sua etica di menestrello o di
giullare errante, che è stato proposto per il premio Nobel per la
letteratura, e che ormai nessuno più dubita che è, anche, un grande poeta.
Certo molte cose sono cambiate anche per me dal 1972. Mia figlia adesso ha
trentun anni e fa il medico a Bruxelles (singolare coincidenza per un
padre dylanologo; penso ai versi di When I Paint my Masterpiece: “Well,
after Rome/ I landed in Brussels / Clergymen in uniform / and young girls
pulling muscles”). Cosa avrei potuto scrivere di questo lungo trascorrere
di anni? Avrei potuto parlare della vita di Dylan, dei suoi affari
economici, delle sue esperienze religiose e delle sue numerose relazioni
sentimentali; ma poiché per rigore critico mi ero imposto di ignorare
l’elemento biografico, avrei dovuto continuare, disco dopo disco, a
dissezionare la sua poesia e la sua musica, spiegando come ha continuato a
sperimentare con i più diversi generi musicali divertendosi e
arricchendoli un bel po’, e come la sua poesia è diventata sempre più
profonda, sempre più triste e più straziante (fino ai bellissimi Time Out
of Mind e "Love and Theft"). Avrei potuto, ma ho deciso di non farlo
perché non credo che avrei aggiunto molto di sostanziale a quello che
molti meglio di me già sanno dopo la dozzina di libri importanti che gli
sono stati dedicati (solo in America) e dopo il profluvio di studi
critici, e chissà quante tesi di laurea.
Il fatto è che, rileggendo il mio vecchio saggio, mi sembrava che la
chiave interpretativa del per sempre sfuggente Dylan era ancora valida e
poteva aiutare a capire non solo gli undici-dodici anni della sua prima
attività, ma anche i successivi trenta. Non solo perché risolveva, credo
una volta per tutte, la stucchevole querelle tra i sostenitori di un Dylan
impegnato e gli estimatori dell’arte per l’arte (la sua), ma perché mi
pareva che lo sviluppo artistico di Dylan, nel trentennio successivo a
quando io ne scrivevo, si è svolto esattamente nel senso che avevo
previsto e tracciato, e ciò a conferma della validità delle leggi della
comunicazione (che all’epoca non era trattata in appositi corsi di laurea,
per non dire di facoltà), le quali leggi non sono meno bronzee di quelle
della fisica. E poi, anche dove il saggio risultava datato o errato, era
ormai un reperto quasi archeologico, un vecchio amico cui non avrei voluto
fare torto stravolgendolo. Così mi sono limitato a fare alcune correzioni,
a chiarire (spero) con qualche inciso alcuni passi alquanto ermetici e a
rifare, senza guardare quelle originali, le traduzioni dei testi di Dylan,
che tanto erano piaciute ad alcuni e tanto erano dispiaciute ad altri.
Adesso il saggio-tesi di laurea-introduzione mancata, naviga su internet.
A tutti i dylanologi un saluto affettuoso: “I’m still on that road”
(S.Rizzo, settembre 2003).
--------------------------------------------------------------------------------
I. Il fenomeno Bob Dylan: contesto e influenze letterarie
1973. Sono undici anni che Bob Dylan alias Robert Zimmenman ha inciso il
suo primo disco long-playing e dodici anni che arrivò per la prima volta a
New York dall’Ovest in cerca di successo, ennesimo esempio del binomio di
attrazione campagna-città, che ha caratterizzato la vita letteraria e
artistica americana almeno dalla metà dell’800.
Dieci anni importanti gli anni ’60 per l’America: durante quel decennio
nacque e maturò il grande movimento di protesta che, all’insegna dei
diritti civili e dell’uguaglianza per i negri, sensibilizzò la opinione
pubblica, soprattutto i giovani, a quei temi di giustizia sociale e di
libertà che erano scomparsi dal dibattito politico con la fine degli anni
’30. Poi fu la guerra del Vietnam, e il travaglio ideale di molti giovani
progressisti si tramutò in frattura interna, senso di colpa e isolamento
per alcuni, radicalizzazione della lotta per altri. Gli assassinii
politici, la violenza della reazione che si scatenò in patria e, ben più
terribilmente, sugli altopiani e nelle valli dell’Indocina, ingenerarono
quel diffuso senso di sfiducia nelle istituzioni, di crollo del sogno
americano, che fu l’aspetto più caratteristico della vita politica e
culturale americana di quei primi anni ’70 e culminò con lo scandalo del
Watergate.
Ma allora, verso la metà degli anni ’60, quando ancora molti giovani non
erano riparati in esilio per sfuggire alla guerra, e i misfatti peggiori
del militarismo dovevano ancora essere perpetrati, il senso di impegno, di
rinnovamento, di una “nuova frontiera” (come la chiamò J.F. Kennedy)
ideale da raggiungere, era il tema dominante nel grande concerto di
strumenti, spesso cacofonici e discordi, della vita sociale.
Quello che soltanto pochi allora incominciavano a capire è che gli
strumenti erano cambiati. Si sentiva vagamente che il mondo non era più lo
stesso. Macchine, televisori, ascensori, jet, calcolatori elettronici (ma
PC, CD e internet non esistevano ancora e neppure erano immaginati),
stampa, pubblicità, un frastuono assordante di immagini e rumori
(“ineluctable modality of the visibile” -- Joyce) che si muovevano sempre
più veloci sulla fitta rete di autostrade, di onde radio, di cunicoli nei
grattacieli. E’ l’accendersi e spegnersi delle luci di comando che danno
il via ai mille processi di stimolo-risposta, attraverso i quali
l’individuo, incapsulato nelle dense maglie di messaggi autogenerantisi
(“superfetation of to eon” – Eliot) non può che scegliere fra migliaia di
alternative equivalenti. E’, in concreto, il processo di sempre maggiore
concentrazione, intensificazione e ramificazione dei sistemi produttivi e
informativi a tutti i livelli; il crearsi di una nuova società tribale di
comunicazione istantanea, il nascere di un cervello elettronico “globale”
per il quale i significati non sono che messaggi – spogliati di contenuto
semantico -- e i messaggi nient’altro che varianti nel potenziale di
attivazione della rete.
Due realtà queste, quella politica e quella tecnologica, che cambiarono
negli anni ’60 il volto dell’America, e non solo dell’America, come mai
era avvenuto precedentemente, provocando un salto di qualità verso
qualcosa di radicalmente diverso dal passato. E’, comunque nel nesso fra
politica e tecnologia, fra contenuto e mezzo di comunicazione che io credo
vada cercata la spiegazione del fenomeno Bob Dylan, cioè l’aspetto
differenziante e più specifico della sua poesia elettronica rispetto a
quella della tradizione letteraria scritta.
Perché Bob Dylan fu un fenomeno. Arrivato a New York ragazzino imberbe e
complessato, divenne presto un mito popolare oltre ogni proporzione, più
grande perfino di quell’Elvis Presley che aveva sempre sognato di emulare.
Povero come tutti i giovani alla ventura, quando viaggiare con lo zaino in
spalla non era ancora passatempo alla moda per i figli dei ricchi, era
affamato di tutto: di notorietà, di successo, di amore. E ha ottenuto
tutto. Prima di approdare, trentenne, al pacifico traguardo della vita di
campagna con la moglie e i tre figli, è stato l’idolo di una intera
generazione di giovani, ha venduto dischi in milioni di copie ed è stato
applaudito da folle quali in America in precedenza solo i revival
religiosi di Billy Graham o gli spettacoli sportivi erano riusciti a
radunare.
Quindi, un successo rapido (praticamente senza gavetta) e travolgente fin
dai primi anni, degno di star della canzone come i Beatles o, qualche anno
prima, Elvis Presley. E tuttavia la legge della rapida obsolescenza che
governa lo star system -- che crea e distrugge carriere per il mai sazio
bisogno di dare carne fresca in pasto al dio-moloch, il pubblico -- sembra
non avere colpito Dylan come invece ha fatto con tanti altri divi prima e
dopo di lui. La sua popolarità, altissima ancora qualche anno fa, proprio
perché stimolata dalle sue reticenze, dalle sue fughe e reclusioni, è
stata sì erosa da quegli stessi mass-media che l’hanno creata, ma lui è
riuscito a sfuggire, come “l’agile trapezista” di alcune sue canzoni, alla
minaccia che il suo personaggio rappresentava per sé stesso; non è rimasto
inchiodato dal classico spillo eliotiano “pinned and wriggling on the
wall”: mito disseccato e consumato. Al contrario, a 60 anni, è ancora un
profeta amato e onorato da tre (almeno) generazioni di ascoltatori.
E’ importante, per capire come questo sia potuto succedere, esaminare il
rapporto fra Bob Dylan e il mezzo di comunicazione di massa (il disco, la
radio – non la televisione, che ha sempre aborrito) da lui usato, non
soltanto perché esso è stato lo strumento amplificatore della sua
popolarità, ma soprattutto perché ha influenzato il contenuto delle sue
canzoni. Sono convinto, ed è la tesi centrale di questo lavoro, che la
chiave dell’evoluzione stilistica e contenutistica di Dylan – fenomeno
senza precedenti nella letteratura (ma appunto forse proprio perché non si
tratta semplicemente o soltanto di letteratura) – vada ricercata nel suo
rapporto problematico e solo parzialmente consapevole fra contenuti e
mezzo espressivo: dai caffè del Village per pochi affezionati, alle
migliaia della nicchia di mercato dei dischi folk, alle centinaia di
migliaia di Woodstock, ai milioni del mercato discografico e, infine, alla
presenza ubiquita sulla rete.
Avrebbe potuto ad un certo punto starsene seduto sui milioni di dollari
guadagnati, fermarsi, lesinare i concerti e le apparizioni in pubblico,
gestire oculatamente la propria immagine. E invece no; a partire dagli
anni ’70, dopo gli anni della Rolling Thunder Review, riprende frenetico
il suo never-ending tour: migliaia di concerti in piccole città di
provincia (qualche volta ogni sera in una città diversa) e all’estero,
come se attraverso la fatica fisica e il suo movimento perpetuo volesse
sfuggire al sistema che cerca di incapsularlo, mentre invece lui vuole
disperatamente preservare il carattere individuale del proprio messaggio.
E’ per questo motivo che Dylan cantante e poeta sfugge, almeno in parte,
ai normali criteri di indagine critica. Non dico naturalmente che certe
influenze non siano rintracciabili; prima fra tutte, in ordine di tempo,
se non altro, è quella della poesia popolare americana, del ritmo e del
lessico dei blues negri, dei canti di lavoro e di protesta degli anni’30,
con cui Dylan venne in contatto giovanissimo e che ricercò poi con lo zelo
di un appassionante archeologo. Perché non bisogna dimenticare che il
mondo degli hobos, dei tramps, dei migrants, il mondo degli emarginati e
dei diseredati, non fu mai veramente il mondo di Dylan, nato in una
famiglia di piccoli commercianti ebrei e cresciuto nell’ambiente
convezionale di una high school del Minnesota settentrionale; anche se
certo il ragazzo Zimmerman era pieno di inquietudini, senza sapere che
direzione prendere, come tanti altri giovanni della provincia americana
degli anni ‘50 (Thomas Wolfe, J.D. Salinger, Truman Capote, ecc. ecc.)
prima che Kerouac a Ginsberg aprissero nuove prospettive di una diversa
sensibilità, quella dei beat.
Quanto alle influenze più specificamente letterarie, agli echi dei
richiami di cui è densa la sua poesia, esse sono meno facilmente
tracciabili. E’ senz’altro vero che certi temi di fondo della poesia
dylaniana, come certi atteggiamenti o stati d’animo, sono riconducibili ad
altrettanti filoni della letteratura e della sensibilità nordamericana. Vi
è naturalmente il tema della strada e del viaggio, direttamente mediato
della letteratura beat degli anni ’50 (Kerouac, Corso, Ginsberg), ma che
affonda le sue radici nell’America del Mississippi di Mark Twain, un
autore che, per il suo humor amaro, il profondo senso morale, il lirismo
nostalgico, lo sguardo rivolto agli strati bassi della società, è molto
vicino a Bob Dylan. Vi è poi il tema della protesta sociale, che non solo
nei contenuti populistici, ma anche nel linguaggio di certe canzoni, pare
riallacciarsi direttamente allo stile cinematico, fatto di parole
pregnanti di frasi mozze, espressionistiche, di un Dos Passos. Ancora,
l’amore per la terra, l’entusiasmo per il grande continente vergine,
ricolmo di promesse di rinnovamento e di purezza, che è una delle
caratteristiche, ad esempio di S.V. Bennet (American Names, Invocation),
sono sentimenti comuni anche al Dylan di Let me Die in my Footsteps o
delle canzoni di New Morning. E soprattutto il tema della maturazione
attraverso la colpa, della cacciata dall’Eden, del giovane che non può
tornare indietro a un passato di innocenza perduta cui aspira – tema
centrale della poesia di Dylan – è presente anche in buona parte della
letteratura americana del ‘900, da Wolfe a F.S. Fitzgerald a Sherwood
Anderson.
Ma rilevando queste influenze non diciamo molto di più del fatto che Dylan
è nato nel Minnesota (come Sinclair Lewis e Scott Fitzgerald) ed è
cresciuto muovendosi nel contesto di quel Midwest che è anche la matrice
di fondo di T.S. Eliot, di Thomas Wolfe, di John Steinbeck. Il poco che
sappiamo della sua vita di adolescente tormentato e introverso, prima del
suo arrivo a New York, non ci consente di determinare i precisi punti di
contatto con la tradizione letteraria americana; non sappiamo quali
letture abbia fatto da ragazzo, da dove sia venuta quella straordinaria e
improvvisa esplosione di ricchezza poetica e di sensibilità musicale che
si manifesta fin dai suoi primi dischi quando è ancora poco più che
ventenne; tanto più che quel mondo di cui ci sembra di riconoscere gli
echi nella sua poesia non trovava già più riscontro nella realtà
quotidiana degli anni ’50 e ’60; il mondo era cambiato, gli hobos, quasi
come gli antichi cavalieri erranti, erano scomparsi; era tempo di bike
boys e di rock and roll (“You can’t hop a jet plane / like you can a
freight train” dirà una bella canzone di Gordon Lightfoot nel disco di
molti anni dopo Self Portrait).
E ciononostante non possiamo considerare Dylan un semplice epigono in
musica del realismo populistico o intimistico, a seconda dei casi, degli
anni ’30 (Woody Guthrie, Leadbelly, Cisco Huston). Quello che ancora una
volta diventa determinante per mettere a fuoco la personalità del
cantante-poeta è il rapporto fra contenuti – più o meno intensamente
vissuti o adolescenzialmente reinventati – e il mezzo di comunicazione.
--------------------------------------------------------------------------------
II. Messaggio poetico e comunicazione di massa
Dylan non è stato soltanto creato dai mass-media al pari di altri divi che
godettero di immensa popolarità. Il suo uso dei mezzi di comunicazione
denota consapevolezza e una raffinata attenzione al loro modo di operare.
E non mi riferisco soltanto a quella abile e sfumata gestione della
propria personalità caratteristica di un intelligente divismo. In tutta la
sua vita di figura pubblica Dylan si è servito dei mass-media non solo
come strumento neutro di amplificazione, di diffusione, ma come il suo
mezzo di espressione, manipolandoli e servendosene come soltanto ci si può
servire di ciò che è intimamente acquisito. La radio e i dischi erano per
lui l’unico modo di raggiungere la gente. Diceva già nel 1965:
L’unico posto dove succede qualcosa è alla radio e nei dischi, è là che
uno trova la gente… I musei non sono che cimiteri. I quadri dovrebbero
stare appesi nei ristoranti, nei grandi magazzini, nelle stazioni di
servizio, nei gabinetti. I grandi quadri dovrebbero stare dove sta la
gente (1).
I libri invece non lo interessavano istintivamente. Sostanzialmente li
considerava troppo lenti come oggetti di comunicazione e incapaci di
cogliere quello che per lui solo contava, la “sensazione” nell’aria.
Ancora, nella stessa intervista:
La mia testa era piena di musica. Cercavo di leggere, ma di solito
smettevo poco dopo. Non sono mai stato molto rapido nelle mie letture; i
miei pensieri non seguivano le cose scritte, andavano alla ricerca di
quella “sensazione” che era nell’aria. Io cercavo di afferrarla e di
scriverla in qualche modo servendomi come guida della mia formazione
musicale (2).
Insomma in Dylan cantante pare si realizzi la legge, formulata da McLuhan
(3), per cui un mezzo di comunicazione superiore (più veloce, sicuro,
ampio) ha sempre come proprio contenuto il mezzo inferiore (più lento,
soggetto ad errori, limitato) di cui modifica il significato. Un filosofo
italiano, Guido Calogero, spiegava nel primo volume della sua Storia della
logica antica (4) come fosse cambiato non tanto il linguaggio quanto il
modo di pensare dei Greci quando incominciarono a servirsi della
scrittura, trasferendovi i suoni del loro parlare. Lo stesso MaLuhan ha
messo in evidenza il significato rivoluzionario del libro stampato per la
cultura occidentale, e ricordava come lo stile frammentato e
impressionistico di Hemingway fosse direttamente legato al fatto che egli
scrivesse a macchina (così come la lunghezza di una frase scritta con
penna e calamaio è dettata – inconsapevolmente – dalla capienza del
pennino). I nessi, insomma, fra mezzo di comunicazione e contenuto da
comunicare non sono esclusivamente strumentali: un mezzo non è mai neutro
e modifica, in misura maggiore o minore in base alle sue specifiche
caratteristiche, il messaggio che gli si affida. Un mezzo di comunicazione
di massa (la radio, la televisione, ma anche le autostrade e i vestiti su
misura, i McDonald, i drive-in, le case prefabbricate – per rimanere ad
alcune delle innovazioni degli anni ’50) condiziona il proprio contenuto
apparentemente utilitario in un modo e a un livello di cui non è facile
rendersi conto, ma che è nondimeno reale e pervasivo. Che effetto e che
significato abbiano, ad esempio, le immagini televisive subliminali non
solo sul linguaggio, ma anche sul nostro modo di pensare, di agire, di
desiderare, di concepire la realtà che ci circonda, dovremmo ormai
saperlo. Certo, sospettiamo che molto stia avvenendo fuori e dentro di noi
(“Something is happening / And you don’t know what it is / Do you, Mr
Jones?” (5) ), di cui non ci avvediamo o che non capiamo perché non
abbiamo ancora imparato a vivere in un mondo elettronico di massa.
In Bob Dylan poeta-cantante, invece, il mezzo elettronico di diffusione fa
proprio – consapevolmente -- il contenuto verbale, lo trasforma e lo
immette nella rete sotto forma di canzone. Oppure, se si pensa la metafora
troppo futuribile, diremo che Dylan, che cinquant’anni fa sarebbe stato un
poeta della parola stampata e qualche secolo fa (come lui stesso dichiarò)
avrebbe potuto essere uno studioso del Talmud, oggi in America decide di
diventare un cantante, anzi un menestrello (6). E questo vuol dire
innanzitutto volere diventare famoso, perché con il mezzo elettronico (a
differenza di quanto avviene con il libro) il successo come popolarità è
precisamente esistenza sulla rete, presenza come centro di comunicazione
indipendente da ciò (il contenuto) che si vuol comunicare. Ma vuol dire
anche che questo contenuto verbale non è mai stato concepito da Dylan come
a sé stante, ma sempre come musica, cioè in quella forma che meglio gli
permetteva di immettersi (e di restare) sulla rete.
In questo Dylan era aiutato dal suo contesto, dalle sue doti soggettive,
ma anche dai suoi limiti oggettivi perché storici e culturali: vivere cioè
negli Stati Uniti (dove la rete di comunicazioni era negli anni ’60
notevolmente più sviluppata che in Europa), avere quello che si chiama uno
spiccato temperamento musicale e, soprattutto, essere libero da
condizionamenti culturali in favore della carta stampata o della
comunicazione discorsiva: non avere insomma né dimestichezza né passione
per il cosiddetto grande patrimonio letterario dell’Occidente, se non
nella misura in cui questo gli si presentava già massificato (cioè
svuotato di contenuto dirompente) per esigenze di comunicazione.
Le antologie scolastiche, le surveys di letteratura, i corsi di
apprezzamento artistico, i programmi di spiritual enrichment delle high
schools e dei colleges americani, sono queste le fonti della formazione
culturale di Dylan. E’ da questo “patrimonio” già massificato e non
storicizzato che egli trae i suoi riferimenti letterari, i quali così
perdono per la riflessione critica il valore di indizi di un personale
iter intellettuale-culturale. A rischio di annoiare i lettori vorrei
aggiungere che ciò che conta in una antologia di letteratura non è la
maggiore o minore oculatezza della scelta dei brani e degli autori, non
sono le più o meno perspicue introduzioni, i cappelli, le note. Al di
sopra dei distinguo del tecnico letterario, il compilatore, vi è l’entità
fisica del libro; al di sopra della varietà dei significati, vi è la
sostanziale identità provocata dalla frammentazione della materia secondo
le esigenze didattiche della scuola di massa. La massificazione dei
programmi di insegnamento comporta una necessaria deformazione del
contenuto insegnato, nonostante le pudibonde evoluzioni di molti
scrupolosi professori. Nel mortaio dell’alchimista il profumo della rosa
va perduto, ma una volta imbottigliatolo e messo sugli scaffali di un
grande magazzino si crede di avere reso accessibile a tutti la sua
sostanza, e in effetti è così (basta intendersi sulla differenza tra una
rosa e una boccetta di profumo).
Non è facile e non è immediato per chi si appresti a leggere le canzoni,
divenute poesie, di un poeta-cantante essere pienamente consapevole di
questo fatto fondamentale della cultura contemporanea. Naturalmente, ogni
cosa può essere stampata, ma la stampa può comunicare (nel senso di
fornire informazioni ai fini della conoscenza e eventualmente dell’azione)
soltanto nella misura in cui ciò che viene comunicato si inserisce nella
preesistente rete di mezzi di comunicazione. Molto sinteticamente, il
potenziale di comunicazione di uno scritto è dato, più che dal suo
contenuto e dal numero di copie vendute, dalla capacità di reazione
all’informazione che il sistema comunicativo permette. Il sistema non solo
vanifica, ma tende ad escludere come “disturbo” (rumore di fondo) ogni
episodio di comunicazione che non sia coerente (“allineato”) con le
potenzialità della rete e le sue finalità, per quanto non dichiarate e
inconsapevoli. L’informazione viene definita sempre più come ciò che
determina una reazione e, dove questa manchi, l’informazione è
oggettivamente nulla.
Sono considerazioni queste da tenere presenti anche in relazione al
fenomeno Bob Dylan per capire il significato più profondo del suo ripudio
della canzone di protesta prima, della canzone a tesi poi, della canzone
profetica in ultimo (a parte la spiegazione immediata e soggettiva, in una
certa misura sempre legittima sul piano dei comportamenti – ma che io non
condivido -- del voltagabbana, del venduto al sistema, ecc.).
Se c’è un settore dell’industria culturale particolarmente illuminante per
capire questo rapporto multidimensionale fra la rete di distribuzione e
l’informazione, certo è quello della produzione del libro, soprattutto (ma
non esclusivamente) in America dove il fenomeno si presenta in tutta la
sua ampiezza. Tortuose e altamente sistemiche sono le strade della
saggistica, ma per la narrativa il meccanismo è semplice: la casa editrice
commissiona a scatola chiusa il romanzo (scegliendo l’autore in una rosa
di ugualmente competenti e, magari, mediocremente noti), impegnandosi poi
a venderlo (cioè a farlo comperare) al pubblico con tutte le necessarie
tecniche pubblicitarie e di persuasione occulta.
E’ il caso di Tarantula, programmato, commissionato a Dylan e
pubblicizzato in anticipo senza che a lui nemmeno fosse passato per la
mente di scrivere un libro, e pubblicato poi per forza (a termini di
contratto) contro la sua volontà. Racconta Dylan:
E’ una lunga storia. Ebbe inizio quando io cominciai a vendere un sacco di
dischi e le maggiori riviste si misero a scrivere e a fare pubblicità su
questo “giovane astro nascente”. Insomma l’industria del libro è quello
che è, e le case editrici cominciarono a spedirmi dei contratti, perché
dopo i concerti io davo delle interviste e i giornalisti mi chiedevano se
scrivevo altre cose. “Mah, non scrivo nient’altro”, dicevo, e loro allora
dicevano “Via, scommetto che lei scrive dell’altro”…Poi le case editrici
mi mandarono i contratti e noi scegliemmo il più vantaggioso. Perché? Non
lo so. Perché mi chiesero di farlo, non lo so. Comunque a quel punto io
dovevo scrivere un libro…(7)
E’ interessante ricordare anche che il contratto di Dylan con la sua casa
discografica, la Columbia, (di cui non si conoscevano i termini esatti
(8), ma si sa che nel 1968 la MGM aveva offerto a Dylan un milione di
dollari solo per cambiare etichetta) lo obbliga a produrre un disco
all’anno, pena gravi sanzioni legali. Meccanismo di incentivazione questo
che taluni sono addirittura arrivati a lodare in quanto stimolerebbe la
capacità creativa di un artista spingendolo a concentrarsi. Si tratta
naturalmente di un fenomeno caratteristico di tutta l’arte e la
letteratura moderna, ma che solo recentemente ha reso evidente, nel
complesso rapporto individuo/industria culturale una spiegazione più
profonda di quella fornita dalla semplice pressione economica.
La storia individuale di Dylan, valutabile secondo i normali criteri di
giudizio, oltre a essere ovviamente la sua storia è anche in buona misura
emblematica di un processo più vasto di svuotamento del valore semantico
nell’America di oggi. La particolarità, la genialità di Dylan, o se si
vuole la sua astuzia di artista, sta forse precisamente nel fatto che
egli, consapevolmente o inconsapevolmente, si è servito di questo
processo, mostrando un’intuitiva comprensione per lo stato attuale del
problema di fondo di tutta l’arte moderna: il rapporto fra espressione
individuale e pubblico così come si realizza concretamente attraverso la
mediazione della industria culturale. Un problema che in passato si è
creduto di potere ridurre al binomio antinomico letteratura impegnata /
letteratura di evasione, ma che si è al contrario andato ulteriormente
complicando per la grande crescita dei mezzi di comunicazione di massa.
Cosicché, lungi dall’essere risolvibile con inviti moralizzanti, esso si
configura in modo del tutto impersonale come il problema della possibilità
di esistenza e diffusione di un messaggio sulla rete di comunicazione. Non
è insomma più l’intenzione dell’artista (la sua autenticità, il suo
impegno) a determinare il valore informativo del messaggio, ma le
caratteristiche della rete, che accoglierà certi messaggi diffondendoli
attraverso di essa, secondo un modello che non è più quello lineare,
tripartito, della comunicazione verbale (trasmittente, messaggio,
ricevente), ma è quello circolare della comunicazione elettronica:
contemporaneo riverberare di tutta la rete.
Secondo questa impostazione sarà quindi da considerare velleitario ogni
messaggio che, per quanto bene intenzionato, non tenga conto di questa
complessa realtà e delle effettive possibilità del comunicare, e creda di
essere comunicazione vera, efficace, pregnante, solo perché è “autentica”,
magari sofferta, espressione individuale.
In questo senso è stata velleitaria molta della protesta nei confronti
delle istituzioni in America, molti degli accorati inviti alla giustizia,
alla responsabilità, alla solidarietà, molti dei patetici tentativi di
esprimere la propria individualità (dalla carta da lettere personalizzata,
all’attuale voga anti-computer, al rifiuto del prodotto industrializzato
rispetto a quello artigianale, ecc.). Intendiamoci, si tratta di cose
buone che denotano una buona intenzione, individuale o di gruppo, in chi
le propugna, ma sono velleitarie nel senso che in ogni caso è la corrente,
e le grandi forze sociali che operano in essa, che trasporta tutti, sia
gli apocalittici che gli integrati (secondo la formula di Umberto Eco). In
questo senso precisamente era velleitario anche Dylan quando cantava
canzoni di protesta con un messaggio sociale preciso, ma scarsamente
“comunicabile”, nonostante i milioni di fans (e destinato, come purtroppo
abbiamo visto, al fallimento), e forse anche dopo quando divenne il
profeta della liberazione interiore. Forse non è velleitario adesso che
non si identifica più con il contenuto delle sue canzoni, rifiuta ogni
esplicito impegno politico, ogni ruolo guida, e si limita a scrivere
canzoni e a cantarle, a metterle in scena in giro per il mondo. Si vede
chiaramente che non essere velleitario non è necessariamente una buona
cosa, almeno quando l’alternativa sia fra l’inutilità e la passività, fra
la vanificazione del contenuto e il silenzio della banalità, due corni
questi di un dilemma in cui ancora si sta dibattendo la letteratura e
l’arte moderna, e con essa, da qualche anno, Bob Dylan ormai nel pieno
della sua maturità di artista.
La conclusione che possiamo trarre da queste considerazioni, e a cui anche
Dylan sembra essere arrivato, è che se si vuole veramente recuperare la
comunicazione non si tratta di trovare parole nuove e più autentiche, ma
di cambiare le possibilità di comunicare della rete. Per parte sua, lui si
limita a “fare il proprio lavoro” (9).
Dylan non ha un temperamento politico e, a parte la sua militanza nel
movimento per i diritti civili e per la pace, fra il ’61 ed il ’63, il suo
disinteresse per le vicende politiche del suo paese lo ha ampiamente
dimostrato. Ma certo è un artista e se da un lato non è interessato a
cambiare la possibilità di comunicazione del sistema, dall’altro, in
quanto artista, gli preme di potersi esprimere efficacemente. Deve invece
avere avvertito il suono vuoto di certi suoi messaggi quando, usciti dalle
sue labbra, gli ritornavano amplificati e svuotati, inautentici, come
fenomeni di massa. Nel 1965, quando era già nella sua seconda fase, quella
del folk-rock, così si espresse su quel primo periodo di successo:
Andavo bene all’epoca, cantando e suonando con la mia chitarra. Era una
cosa sicura, capite, una cosa sicura. Non potevo continuare e suonare a
quel modo… Sapevo quello che il pubblico avrebbe fatto, come avrebbe
reagito. Era tutto molto automatico (10).
Allora smise di dire cose pregnanti, di formulare messaggi impegnati.
Dissacrò anche le canzoni che gli erano più care (si pensi alla melensa
versione della bella lirica Girl from the North Country o alle tante
irriconoscibili versioni di Blowing in the Wind, quasi una provocazione
per il suo pubblico – ma una provocazione a pensare) per concentrarsi
quasi esclusivamente a giocare e a combinare nella mente (e sulla carta e
coi suoni) il ricchissimo patrimonio di musiche americane, di hillbilly,
di jazz, di canzoni popolari, di blues, di country, di western, di folk,
di rock and roll. Adesso in questa sua ultima fase pare avere scoperto il
fascino della banalità, della parola svuotata di ogni messaggio, divenuta
guscio liso e grigiastro, ma allo stesso tempo reale proprio in questo e
all’improvviso, dopo il lungo viaggio nel tempo e nei meandri del sistema,
di nuovo magica, oggetto inespugnabile.
Anche se quest’ultima fase della sua poesia (ultima in ordine di tempo,
perché altre siamo sicuri ne verranno, perché – come lui stesso ha detto –
un muscista è un giocoliere, un trapezista, un uomo del circo sempre in
movimento) non è la più bella o la più artisticamente pregnante, tuttavia
è quella che io trovo più interessante perché mi sembra che più delle
altre metta in evidenza (rappresentando quasi un compimento) il nesso tra
messaggio poetico e strumento di comunicazione di massa; un nesso tutto
particolare e senza precedenti, perché elettronico, in un certo senso
emblematico della nostra contemporaneità (o post-modernità), che vale la
pena approfondire, non soltanto per quello che ci può chiarire dell’iter
psicologico di un artista, ma per quanto ci può dire del significato della
sua presenza, non solo per il mondo della canzone, ma per tutta la
sensibilità contemporanea. Ma intanto esaminiamo la prima fase, quella
detta dell’impegno politico, che dopotutto durò solo poco più di un
biennio.
--------------------------------------------------------------------------------
III. La fase politica
Quanto detto fino adesso non modifica, naturalmente, il concreto sviluppo
poetico e musicale di Dylan. Vuole soltanto cercare di capirlo oltre le
immediate (ma per questo non meno giuste) conclusioni che su di esso si
possono trarre. Nell’arco di dieci anni l’attività di Dylan ha avuto un
andamento parabolico, raggiungendo un massimo (quantitativo e qualitativo)
verso il 1966, interrompendosi con l’incidente motociclistico e
decrescendo poi negli anni seguenti. Anche il suo impegno politico e
sociale, intenso nei primi anni, andò versò la metà degli anni ’60
acquistando forme diverse, più personali e meno direttamente politiche,
per poi svanire quasi del tutto negli ultimi dischi. La conclusione
immediata e furibonda dei suoi ammiratori è stata che Dylan non ha più
niente da dire, è ormai decisamente tramontato, oppure sta attraversando
un periodo (che ormai dura da qualche anno) di scarsa creatività. Secondo
questo modo di ragionare (che non condivido), il successo, la ricchezza
gli avrebbero dato alla testa, così che adesso non ha più voglia di
protestare, non si identifica più con i sofferenti, si è in un certo senso
venduto al sistema e rappacificato con il mondo, che con lui non è certo
stato cattivo.
Ma questa conclusione, per altro diffusissima, non ci porterebbe più in là
di un giudizio psicologico e di un altro etico-politico. Può darsi che sia
tutto qui e che non ci sia altro da dire sul fenomeno Bob Dylan, perché
del resto è stato così in molti casi prima del suo. Ma a spingerci a
ricercare spiegazioni più ampie sono precisamente i testi delle canzoni.
Da esse, come pure dalle non molte interviste, emerge una personalità
complessa e che sfugge alle facili tipizzazioni: un uomo attento a tutte
le sfumature, quasi guardingo, desideroso soprattutto di salvaguardare,
cambiando maschere come un clown e volando come un trapezista, il suo
privato (e sempre più riposto) mondo di affetti e di valori.
Quando Dylan incise il suo primo disco nel 1962 era arrivato a New York da
poco più di un anno. In quell’anno, dando per la prima volta prova della
sua capacità di adattamento e di penetrazione, oltre che del suo talento,
era riuscito ad emergere nel caotico mondo del Greenwich Village,
affollato di artisti, di beatnicks sovversivi e di sinistra (come li
chiamava la grande stampa d’allora mescolando ‘beat’ con ‘sputnik’, il
satellite russo simbolo nell’immaginario della potenza sovietica) di
giovani scappati di casa e di cantanti della nuova moda folk, facendosi
notare dal critico del New York Times, Robert Shelton. Questi, già allora
ascoltandolo al Gerde’s Folk Center, ne aveva evidenziato alcuni tratti
che gli riconosciamo ancora:
Il signor Dylan sembra un incrocio fra un cantore di coro e un vagabondo,
ha uno sguardo da cherubino e una massa di capelli riccioluti semicoperti
dal berretto alla Huck Finn…E’ comico e tragico allo stesso tempo, come un
attore di vaudeville nei circuiti di campagna, se ne esce con una varietà
di buffi monologhi musicali (11).
All’epoca Dylan aveva già scritto e musicato numerose canzoni e talking
blues, ma nel primo disco, probabilmente per volontà della casa
discografica, i suoi testi sono soltanto due (se si esclude In my Time of
Dying, poco più di calco da uno spiritual negro); gli altri sono
rifacimenti ed interpretazioni di note canzoni della tradizione folk. Il
primo dei suoi testi Talkin’ New York è una sorta di presentazione
ufficiale, in cui Dylan narra quella che allora voleva si credesse fosse
la sua storia: si presenta come un hobo, un vagabondo d’America, un uomo
maturo e sperimentato dai molti anni sulla strada, che viene dal “West
selvaggio” nella grande città; qui viene indegnamente sfruttato così alla
fine riprende la strada:
Pulled my cap down over my eyes and
Headed out for the western skies (12)
Song to Woody è invece un omaggio al suo “ultimo idolo” (come dirà
altrove), Woody Guthrie, e all’ideale di vita che Woody e gli altri grandi
cantanti folk della sua generazione rappresentavano per il giovane Dylan,
e con cui egli si identificava, non ancora consapevole del distacco (e non
solo di tempo) fra lui e loro, impegnandosi a seguirne l’esempio:
I’m a-leaving’ tomorrow but I could leave today
Somewhere down the road someday
The very last thing that I’d want to do
Is to say I’ve been hitting some hard travelling too (13)
Il debito di Dylan nei confronti di Guthrie, di Cisco (Houston), di Sonny
(Terry), di Leadbelly (Huddie Ledbetter) e degli altri che egli indicava
come “all the good people that travelled with you” è in effetti grande.
Sappiamo che fin dagli anni della adolescenza il giovane Dylan scorazzava
sulla sua motocicletta per tutto il Minnesota alla ricerca di vecchi
dischi folk e di chiunque fosse in grado di insegnargli un nuovo giro di
chitarra o un motivo che non conosceva. Era un infaticabile ascoltatore.
Quando venne nell’Est proprio per conoscere Woody Guthrie (ricoverato per
una male incurabile in un ospedale del New Jersey) e gli altri cantanti
folk – ormai quasi mitici – della cerchia di Woody, continuò con cura il
suo apprendistato di cantautore, ascoltando e assorbendo con una tenacità
e una voracità che, qualche anno dopo, quando era ormai diventato famoso,
ricorderà non senza punte polemiche nel suo primo Dream del 1963. Dylan
ricorda con nostalgia e gratitudine quell’anno di entusiasmi e di
camaraderie:
With half-damp eyes I stared to the room
Where my friends and I ’d spent many an afternoon
Where we together weathered many a storm
Laughing and singing
Till the early hours of the morn (14)
E comunque quella della canzone popolare rimarrà una influenza costante
nella poesia di Dylan. E anche se la sua tematica e il suo linguaggio si
staccheranno sensibilmente – soprattutto nel secondo periodo – dai temi
dei suoi predecessori, essi ritorneranno nuovamente (in un modo indiretto
e con diverso significato) nel terzo, attuale, periodo. In tutto l’arco
della produzione di Dylan non è difficile cogliere non solo echi, ma anche
precisi imprestiti dalla tradizione popolare. Non servirebbero
dimostrazioni, ma alcuni esempi tratti da un confronto con alcuni testi
incisi da Brownie McGhee e Sonny Terry possono essere indicativi del tipo
di influenza linguistica e tematica che operò costantemente su Dylan.
Preachin’ the Blues di McGhee – Terry dice:
I looked down the road far as I could see
E Down the Highway (1963) di Dylan:
So I’m walking down your highway
Just far as my poor eyes can see
If you Lose your Money di McGhee – Terry:
Well love is something
Could get some body killed
Ancora, Down the Highway di Dylan:
Well the way I loved that women
I swear it’s bound to get me killed
Il verso “Well, you’re on my mind baby” di Can’t Help Myself lo ritroviamo
nel titolo di Mama you Been on My Mind (1964) di Dylan.
She’s a married woman
but I love her just the same
Dice Heart in Sorrow di McGhee – Terry; e Outlaw Blues di Dylan (1965):
She’s a brown skinned woman
but I love her just the same
C’è un canto di fuggiaschi negri che dice:
Standin’ on de corner…
Up come a ‘liceman an’ he... (15)
E Dylan nella sua In Search of little Sadie (1970), che certo è una
variazione di una vecchia ballata popolare:
Standing on the corner…
Up stepped the sheriff...
Eccetera, eccetera. Un elenco completo risulterebbe eccessivamente lungo e
nel complesso inutile quando si sia compreso che, nonostante le affinità
di linguaggio e le copiature più o meno consapevoli, le canzoni e i testi
di Dylan rimangono un’altra cosa, perché il loro significato come oggetti
culturali è ben diverso da quello che avevano per i grandi maestri della
canzone folk degli anni ’30. Costoro rivolgevano le loro canzoni di
protesta e di fuga verso un passato per lo più agricolo -- violento e
ingiusto, ma ricordato con nostalgia -- ad un pubblico per il quale la
crisi economica degli anni ’30, la povertà e la disoccupazione erano
realtà ben immediate. Il revival folk iniziato alla fine degli anni ’50,
in cui si inserisce la figura di Dylan, si rivolge invece a un pubblico di
giovani le cui rivendicazioni sono più ideali che materiali. I beat degli
anni ’50, che militeranno poi nel movimento dei diritti civili, non
lottano per il pane e per la terra, per condizioni minime di
sopravvivenza. Quelle non gli mancavano. Sono degli anticonformisti (nel
senso migliore del termine) alla ricerca di una libertà interiore contro
una società diventata opulenta, ma anche pericolosamente schiava dei
propri pregiudizi. Per loro la canzone folk ha un valore simbolico, al
pari di altri simboli e stili di vita del decennio: la filosofia Zen, le
droghe, la vita sulla strada, il rifiuto del consumismo, l’amore.
Ritornando al primo disco, notiamo che il tema della strada (e quello
connesso dell’hobo) appare fin dall’inizio dominante, anche se in queste
canzoni è ancora sentito come concreto ideale di vita e non nel suo valore
mitico (ed in questo consiste una certa sua artificiosità). Ma fin da
allora compaiono due modi tipici nel temperamento di Dylan, quello
buffonesco di Talkin’ New York e quello accorato di Song to Woody, e due
ritmi, saltellante e incalzante per la grande città, lento e stridente per
la strada e la campagna, a cui corrispondono due modi di sentire,
sarcastico e frenetico l’uno, lirico e sognante l’altro.
Anche grazie alla presentazione di Shelton il disco ebbe un notevole
successo, e le porte degli studi di registrazione della Columbia si
spalancarono l’anno dopo per un Dylan finalmente “a ruota libera”, che
questa volta incise canzoni soltanto sue, divenendo famoso nel giro di
qualche settimana. The Free-Wheeling Bob Dylan contiene una varietà di
temi, ciascuno dei quali ritornerà nei dischi successivi seguendo un suo
proprio sviluppo.
Primo fra tutti quello della canzone di protesta, che non nacque, come
Dylan dirà in seguito (con caratteristica deformazione polemica di sé
stesso), da opportunismo, come se protestare fosse l’unica cosa da fare
per un giovane ambizioso che volesse diventare famoso nel mondo della
canzone. Ad attrarlo alla tematica della protesta fu, da un lato
l’ambiente non conformista del Village, dall’altro tutta la tradizione
della canzone folk, che già negli anni ’30, proprio per merito di Woody
Guthrie, aveva innestato precisi contenuti di protesta sociale nelle forme
intimistiche del country e del blues. E’ la canzone folk di protesta,
probabilmente, che costituisce il punto di contatto di Dylan con la
tradizione populista e socialisteggiante rappresentata da un Dos Passos,
da un J.T. Farrell da un John Steinbeck. Senza dimenticare, comunque, che
la critica del conformismo piccolo-borghese che tanta parte ha nella
satira dylaniana ha un illustre predecessore in un altro grande scrittore
del Minnesota, Sinclair Lewis (16).
L’impegno di Dylan maturò anche concretamente in una serie di iniziative
politiche, oltre che partecipando gratuitamente ai concerti organizzati a
Washington e nel Sud per pubblicizzare la lotta per i diritti civili, a
fianco dei militanti bianchi e neri della NAACP e della SNCC, molti dei
quali Dylan conobbe e frequentò in quegli anni. Il suo impegno si
manifestò, fra l’altro, rifiutando, all’inizio della sua carriera, di
intervenire al prestigioso spettacolo televisivo di Ed Sullivan perché i
dirigenti della trasmissione gli avevamo vietato di cantare un talking
blues contro la reazionaria John Birch Society.
Se Dylan smise in seguito di scrivere canzoni di protesta fu per altri
motivi e non perché il suo impegno fosse stato viziato fin dall’inizio da
opportunismo. All’epoca, anzi, all’inizio di quegli anni ’60 che tanto
sembrarono promettere in direzione di un mondo migliore, aveva detto:
Ci sono altre cose al mondo oltre all’amore e al sesso che sono anche
importanti; e la gente non dovrebbe voltarsi dall’altra parte solo perché
non sono belle da vedere. Altrimenti come farà il mondo a diventare
migliore se ci rifiuteremo di guardarle (17).
Parole nobili nel loro giovanile entusiasmo che riecheggiano i versi
famosi di Blowing in the Wind, la canzone che per milioni di giovani
doveva diventare l’inno della liberazione, esprimendo la loro ansia per un
più giusto mondo a venire:
Yes, and how many times can a man turn his head
And pretend that he just doesn’t see
The answer my friend is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind (18)
Con queste prime canzoni di protesta Dylan puntava un dito accusatore sui
mali della società: la guerra, la fame, lo sfruttamento in Blowing in the
Wind, i fabbricanti di armi (quello che nel corso della guerra del Vietnam
si chiamerà poi il complesso militare-industriale) in Masters of War, il
razzismo in Oxford Town.
Ma già nella bellissima canzone A Hard Rain’s Gonna Fall (che ricalca il
modello della ballata inglese di Lord Randall), sono presenti elementi che
vanno molto al di là della tradizionale canzone di impegno sociale; e sono
precisamente quelli che spingeranno Dylan ad allontanarsi dal movimento
per i diritti civili (senza però mai sconfessarlo) alla ricerca di una più
totale e autentica liberazione. In questa canzone si avverte per la prima
volta che i problemi che contano per il giovane cantautore sono solo
parzialmente sociali, e quindi non possono essere affrontati (e tantomeno
risolti) con l’azione politica, ma anche (e poi soprattutto) con la sola
azione individuale, l’illuminazione di tipo interiore. Accanto alle “lame
affilate”, ai “martelli insanguinati”, agli uomini che muoiono di fame,
della canzone, vi sono altre realtà ed altre tragedie:
I saw ten thousand talkers
Whose tongues were all broken
...
I heard ten thousand whispering
And nobody listening
...
I heard the song of poet
Who died in the gutter
I heard the sound of a clown
Who cried in the alley
...
And I’ll tell it and speak it
And think it and breathe it
And reflect it from the mountains
So all souls can see it (19)
La dura pioggia che deve cadere non è certo soltanto la pioggia del
fall-out atomico (Dylan lo negò esplicitamente); né la tematica di questi
versi e semplicemente protestataria. E’ della salvezza dell’uomo nella sua
totalità che Dylan parla, ed è in quella direzione che sviluppa il suo
impegno etico, anche quando non canterà più canzoni politiche, almeno
finchè conserverà la fiducia nelle parole. E che questa fiducia venga poi
meno, è quanto di più emblematico e “mediaticamente” interessante vi sia
nel fenomeno di Dylan.
Accanto al tema della protesta e della liberazione interiore compare in
questo secondo disco il tema dell’amore, trattato in termini estremamente
personali: dalla lirica, delicata e idealizzata Girl from the North
Country, alla melanconica atmosfera di Down the highway, dove la strada
ricompare non più come orgoglioso simbolo di americana self-reliance, di
autonomia (come in Song to Woody), ma come metafora della solitudine e
della mancanza di radici dell’uomo americano nel suo grande continente.
Tema questo ricorrente nelle canzoni di Dylan come in tutta la tradizione
folk.
Già si è detto come il tema della “strada senza ritorno”, dell’ “innocenza
perduta”, della “memoria non dimenticata”, costituisca, al di là dei nessi
precisi con questo o quello scrittore, uno degli elementi dell’americanità
di Dylan. Scrive Thomas Wolfe in un passo di Of Time and the River (ma un
simile atteggiamento è caratteristico di tutta la tumultuosa opera dello
scrittore del Sud):
Ma questa è la ragione per la quale… le nostre memorie non possono mai
essere dimenticate – perché siamo così perduti, così nudi e così soli in
America… Perché l’America ha mille luci e mille stagioni e noi camminiamo
per le strade, camminiamo per sempre per le strade, camminiamo da soli per
le strade della vita…E’ un volto visto e perso per sempre nella folla, un
occhio che ha guardato, una faccia che ha sorriso ed è svanita su un treno
che passava.
Ma nonostante queste affinità di concezione (e di immagini che ritroveremo
in molte canzoni) con Thomas Wolfe, siamo più tentati di avvicinare Dylan
a F.S. Fitzgerald; e non soltanto per il tono nostalgico, per la tristezza
pacata, per quelle visioni sognanti (ho in mente in questo momento il
racconto Winter Dreams) che sono una delle caratteristiche salienti di
Fitzgerald. Vi è fra i due un’affinità di temperamento e di background.
Anche Fitzgerald, come Dylan, veniva dal Minnesota; anche lui, con il suo
patrimonio di ambizioni e di sensibilità, voleva “farcela” nel mondo della
grande città, e in effetti conquistò – nel breve ed intenso arco della sua
vita – una fama grandissima, rischiando quasi di rimanere intrappolato nel
personaggio che si era creato. Anche Fitzgerald, come Dylan, non riuscì
mai a scrollarsi di dosso la nostalgia per il grande entroterra d’America
(the “Big American Countryside”), che anzi fu uno dei temi ricorrenti,
polo d’opposizione al mondo cittadino alla moda, della sua narrativa.
Accanto al Dylan protestatario e a quello nostalgico, fa la sua comparsa,
in questo secondo disco, il Dylan comico, il pagliaccio, il trapezista,
l’attore di vaudeville, con una vena caustica e grottesca che sarà anche
in seguito una sua costante, e la capacità di combinare situazioni
fantastiche con brandelli di realtà puntigliosamente americana. Così in
Talkin’ World War III blues, oscillanti fra il tragico e il comico,
mosaico di habitat urbano contemporaneo, le cui tessere sono disposte
indifferentemente l’una accanto all’altra sullo stesso piano: psichiatra,
tombino, parcometro, hotdog, telefono, cadillac, rifugio atomico,
presidente Lincoln, compagnia telefonica -- sono solo alcune del
caleidoscopio di immagini che girano vorticosamente nella canzone. E così
nella divertentissima I Shall Be Free con il suo miscuglio di Kennedy (non
ancora assassinato) e Anita Eckberg (La dolce vita era uscito da poco).
Anche qui una fantasia veramente a ruota libera, la capacità di servirsi
di ogni cosa, l’occhio attento a cogliere nel campo visivo il
caratteristico, a qualunque livello di discorso appartenga, senza
distinzioni categoriali. Ancora è un gioco, una tecnica divertente,
un’esercitazione dell’immaginazione fusa unitariamente nel medium
musicale; solo in seguito, nel contesto di un diverso clima psicologico,
emergerà il lato tragico del clown e questa tecnica del mosaico verrà
usata per ritrarre una realtà psichica allucinata, permeata di profondo
pessimismo.
Nel disco successivo, The Times They Are a-Changin’, avvertiamo che
qualcosa sta cambiando anche in Dylan. La denuncia sociale si fa più
complessa e meglio articolata, più consapevole delle pieghe oscure di una
società che è malata e non vuole ammetterlo. La Ballad of Hollis Brown
ritrae la miseria di certe zone sottosviluppate del Sud, così come
l’avevano descritta prima della guerra gli scrittori del realismo e della
protesta sociale. La miseria del Sud, ma anche quella dei grandi ghetti
urbani, del Mid-West e dei monti Appalachiani, contro cui Johnson,
divenuto presidente degli Stati Uniti dopo l’assassinio di Kennedy,
lancerà di lì a poco – proprio in risposta alle crescenti denunce sociali
– la sua retorica, robante “war on poverty”. Nella canzone frutto della
miseria è la disperazione e della disperazione la follia omicida-suicida,
anche se il messaggio finale è temperato da una sorta di ottimismo
compensatore, di tipo religioso, anche questo con radici profondamente
americane, fin dal trascendentalismo di R.W. Emerson.
There’s seven people dead
On a South Dakota farm
Somewhere in the distance
There’s seven people born (20)
Ma c’è nel disco anche la satira sferzante del militarismo di With God on
Our Side (anche questa canzone non priva di risvolti religiosi) e del
razzismo in Only a Pawn in Their Game, che contiene alcuni dei versi più
belli, più sentiti e meglio costruiti di questa prima fase della poesia di
Dylan:
From the poverty shacks
He looks from the cracks to the tracks
And the hoofbeats pound in his brain
And he’s taught how to walk in a pack
Shoot in the back
With his fist in a clinch
To hang and to lynch
To hide ‘neath the hood
To kill with no pain
Like a dog on a chain (21)
Dove versi come: he looks from the cracks to the tracks / and the
hoofbeats pound in his brain mostrano che Dylan ha raggiunto la piena
padronanza del blank verse e sa sfruttare questa straordinaria risorsa
della lingua inglese, ottenendo qui un martellante effetto di chiusura
claustrofobica, di follia e di ottusità omicida.
E poi, ancora, la passione politica del cantante si volge contro il
classismo e lo sfruttamento in The Lonesome Death of Hattie Carroll e
contro lo spettro della disoccupazione e della solitudine nei North
Country Blues.
Ma “i tempi stanno cambiando” ripete insistentemente il ritornello della
prima canzone, freddamente entusiasta e altisonante come un inno nazionale
(e tale ovviamente fu per tutta una generazione di giovani). Ma il
messaggio profondo della canzone è molto più ambiguo e meno ottimista di
quanto non appaia a prima vista, perché se da un lato afferma che “c’è una
battaglia / là fuori che infuria / e presto scuoterà le vostre finestre/
l’ordine sta rapidamente / scomparendo”, dall’altro ci dice che “la ruota
sta ancora girando / e nessuno può dire / chi sarà designato”.
In effetti, il tono complessivo del disco è stranamente contraddittorio.
Al messaggio politico, ottimista e vitale almeno in apparenza, si
accompagna un profondo senso di sfiducia, se non di disperazione e di
abbandono, nella sfera personale. Di questi testi si può dare una lettura
letterale, come testimonianza intimistica di una crisi amorosa in atto;
oppure metaforica, come anticipazione di una crisi politica che ancora
deve maturare. Nel contesto generalmente sconsolato delle canzoni non
esplicitamente politiche vi è solo lo squarcio luminoso e profetico di
When the Ship Comes in, in cui il verso di ispirazione biblica esprime una
visione quasi religiosa: la liberazione che viene con la nave dal mare,
infatti, pare andare molto oltre il conseguimento di libertà civili o di
diritti economici, e indica piuttosto la necessità di una palingenesi, di
un’apocalisse che rigenera distruggendo. Ma soltanto qui. Nelle altre
canzoni il mare, la strada, la campagna sono presenti come simboli di
solitudine, di fallimento, di lontananza. Solitudine che è mancanza di
comunicazione, futilità del parlare. Appare in questi versi un tema
ricorrente della poesia di Dylan, almeno quanto l’altro della liberazione
(cui è intimamente legato), l’incomunicabilità:
When everything I’m saying
you can say it just as good
you’re right from your side
I am right from mine
we’re both just one too many mornings
and a thousand miles behind (22)
La consapevolezza della finitezza del tempo toglie ogni senso di avventura
o di scoperta al viaggio ancora da compiere. Allontanarsi è a un tempo
necessità di fuggire una realtà divenuta intollerabile e aspirazione (in
cui si fondono istanze religiose e miti americani) a rinascere, a
ritornare sulla strada per ritrovare sé stessi.
Oltre a questa dimensione universale, non si può non scorgere nei versi di
Dylan un più preciso e occasionale intento polemico. Il primo verso di
Restless Farewell (“Oh, tutti i soldi che per tutta la mia vita ho speso”)
è un esplicito riferimento al finanziamento da parte di Dylan di varie
iniziative del movimento per i diritti civili. Adesso però le cose sono
cambiate ed è tempo di separarsi dai suoi vecchi amici:
But the battles are done
We’ve killed each one
And the tables full and overflowed
And the corner sign
Says it’s closing time
So I’ll bid farewell and be down the road (23)
C’è poi in questa bella canzone, conclusiva (come si vedrà) di tutto un
periodo, il presagio di una nuova realtà che si svela al poeta: “ma il
buio muore / quando la tenda viene tirata / e gli occhi di qualcuno /
dovranno incontrare l’alba”, e l’esigenza di esprimere un mondo interiore
libero da condizionamenti esterni o da doveri di testimonianza sociale:
“Oh, ogni pensiero che s’aggroviglia / nella mia mente / potrei diventare
pazzo / se non potessi scioglierlo, / ma non deve restare nudo / sotto
occhi che non capiscono”. E infine la volontà di andare avanti, di uscire
dalla polvere delle chiacchiere e dallo sporco del pettegolezzo (perché
già si sapeva che il suo impegno politico era scemato) così come dalla
ridda di polemiche che si era scatenata, con incertezza verso il futuro,
ma anche con matura (ed orgogliosa) consapevolezza della propria missione
poetica:
But if the arrow is straight
And the point is slick
It can pierce trought dust
No matter how thick
So I’ll make my stand
And remain as I am
And bid farewell and not give a damn (24)
--------------------------------------------------------------------------------
IV. La crisi dell’impegno
Quelli che non avevano capito il significato di queste parole, pensando
che si trattasse di un “poetico” addio amoroso, lo capirono con il disco
seguente, e fu un’amara sorpresa per molti. Another Side of Bob Dylan
scopre un’altra faccia di Dylan, gira una pagina su cui non tornerà più
(eccetto una volta sola otto anni più tardi): scompare completamente la
canzone politica. A Nat Hentoff, che aveva invitato ad assistere alla
registrazione, Dylan così presentò il disco:
Non ci saranno canzoni che puntano il dito contro qualcosa. Quei dischi li
ho fatti e non li sconfesso, ma parte di quel saltare sulla scena per
essere ascoltato era perché non c’era nessun altro che faceva canzoni come
quelle. Voglio dire nessuno che mettesse il dito su tutte le cose che non
vanno. Adesso non voglio più scrivere per la gente. Non voglio essere un
“portavoce”… da adesso in poi voglio scrivere dal di dentro e per farlo
debbo tornare a scrivere come scrivevo quando avevo dieci anni, fare
uscire tutto con naturalezza. Il modo come vorrei scrivere è di fare tutto
nello stesso modo di come cammino e di come parlo (25).
Alle accuse di tradimento politico e di mancanza di contenuti sociali
rispondeva semplicemente:
Se qualcosa ha da dire qualcosa sulla morale io voglio sapere che cosa fa.
Lo stesso vale per me. Tutto quello che posso fare è mostrare alla gente
che mi fa delle domande come vivo. Tutto quello che posso fare è essere me
stesso. Non posso dire loro come cambiare le cose, perché c’è un solo modo
per farlo ed è di liberarsi tagliando tutte le catene. E questo è
difficile per la maggior parte della gente (26).
Tutti temi questi -- distacco dalla politica attiva, autonomia morale,
liberazione del comportamento e dell’espressione, libertà totale -- che
ritroveremo articolati concretamente in questo disco ed in quelli
successivi. In Another Side of Bob Dylan, in particolare, l’immediatezza
della polemica spiega il tono quasi programmatico, da manifesto, di alcune
canzoni, che risultano così impoverite da un certo schematismo. D’altro
canto, non dobbiamo dimenticare, adesso che il fumo di quelle battaglie è
lontano, che abbandonando l’arena politica Dylan si poneva al centro di
controversie la cui asprezza era paragonabile solo alla sua enorme
popolarità. In quegli anni asserire che “la libertà non è uguaglianza
nelle scuole” era semplicemente anatema per tutti coloro che si battevano
per integrare le scuole, dove bianchi e neri venivano tenuti separati, e
per milioni di giovani che consideravano Dylan il loro idolo portavoce
della protesta. Pochi seppero capire allora quello che gli eventi (il
fallimento della lotta pacifista e integrazionista, il contraccolpo
durissimo della reazione, la escalation del potere militare) avrebbero
dimostrato: che la libertà stava altrove e che per ottenerla bisognava
decidersi a tagliare tutte le catene.
Canzoni come All I really want to Do e It Ain’t me Babe svolgono una
tematica libertaria (anche se dietro il velo di una metafora amorosa), si
propongono di troncare con il passato. “Non voglio”, dice Dylan:
Simplify you classify you
Deny defy or crucify you
All I really want to do
Is baby be friends with you (27)
...
Go away from my window
Leave at your own chosen speed
I’m not the one you want babe
I’m not the one you need (28)
Canzoni d’amore, certo, ma anche qualcosa di più. Esplicitamente polemica
e politica è invece My Back Pages, che è al tempo stesso critica e
autocritica, lucida e poetica analisi di una crisi ideologica, di una
maturazione: “ah ma ero molto più vecchio allora, sono molto più giovane
adesso”. Essere più giovane per Dylan vuol dire non pensare che la vita è
bianca e nera, non sognare eventi romantici, non credere che la libertà
sia soltanto uguaglianza, rendersi finalmente conto che “la mia esistenza
navigava su battelli di confusione / ammutinamento da poppa a prua”. Il
messaggio di fondo è che la vita è complicata e che non si può credere di
risolvere complessi problemi di fondo (della società o della vita
personale) con facili generalizzazioni o azioni parziali che lasciano il
tempo che trovano, che non bisogna agire secondo schemi prefissati
applicandoli agli altri, ma che bisogna cominciare prima a essere liberi
dal di dentro; e per esserlo bisogna sapersi liberare da ogni legame
artificiale e inutile, agire liberamente e consapevolmente (per liberarsi
dai condizionamenti esterni è necessario prima di tutto esserne
consapevoli): capire sé stessi, essere sé stessi, come primo passo per
essere liberi.
Ritorna così in questo disco un aspetto di Dylan che, pure presente qua e
là, era stato represso nel disco precedente: la vena comica ed
effervescente. Motorpsycho Nightmare e I Shall Be Free n. 10 non sono solo
canzoni di satira politica e di costume, sono in primo luogo gesti
liberatori:
I’m gonna grow my hair down to my feet so strange
So I’ll look like a walking mountain range
Then I’m gonna ride into omaha on a horse
Out to the country club and the golf course
Carry the New York Times, shoot a few holes, blow their minds (29)
Nelle belle canzoni d’amore (To Ramona, I Don’t Believe You, Ballad in
plain D) Dylan analizza con grande delicatezza e maturità di sentimenti
come l’incapacità a essere liberi può impedire di amarsi e renda anzi
l’amore un’altra schiavitù (tanto più triste in quanto così vengono meno
le potenzialità liberatorie che esso contiene), quando: “la mente / è
stata distorta e nutrita / coll’inutile schiuma della bocca”; perché
allora la sofferenza nasce “da situazioni da costrizioni da amici / che ti
drogano e ti costringono / e ti fanno credere / che dovresti essere
proprio come loro”.
Non a caso uno dei personaggi-simbolo di liberazione più ricorrenti in
Dylan è quello dello zingaro, inteso come figura mitica, concretizzazione
quasi magica di una libertà che non è soltanto assenza da condizionamenti,
ma è anche profonda consapevolezza del proprio destino, vitalità, mancanza
di radici, imprevedibilità. In questo periodo di transizione, di
incertezza, di liberazione in atto ma non ancora raggiunta, se da un lato
Dylan annuncia di avere già sentito le “campane della libertà” suonare
“per le schiere dei confusi accusati maltrattati / disillusi o peggio / e
per ogni uomo prigioniero / in tutto l’intero universo”, dall’altro
confessa proprio alla Gipsy Gal, la ragazza zingara della canzone, tutta
la sua ansia per un futuro che certo adesso lui non attende più con la
sicurezza e l’entusiasmo di un tempo:
I am homeless, come and take me
Into reach of your rattling drums.
Let me know, babe, about my fortune
Down along my restless palms
…
Let me know, babe, I got to know, babe,
If it's you my lifelines trace.
…
I been wond'rin' all about me
Ever since I seen you there.
…
I got to know, babe, will I be touching you
So I can tell if I'm really real (30)
--------------------------------------------------------------------------------
V. La fase profetica
Compiuto il gran passo, staccatosi da un passato che lo soffoca e in cui
non si riconosce, nonostante l’incertezza del presente, Dylan ha ora a
disposizione tutte le risorse della sua fantasia per scoprire se è
“veramente vero”: risorse che dispiegherà nei tre dischi successivi con
un’ansia e un ritmo sempre più frenetici, con una varietà di temi e di
toni, con una tale ricchezza di simboli e di immagini, impossibili da
analizzare, in tutto il loro complesso intrecciarsi, nelle pagine di un
saggio introduttivo.
Tracciato quindi lo sviluppo della poetica di Dylan fino all’importante
punto dell’abbandono della politica attiva e della scoperta di un’altra e
più profonda libertà, esamineremo adesso, l’ulteriore svolgersi di questa
seconda fase della sua attività. Fase che potè apparire in netto e
inspiegabile contrasto con la precedente, anche per la novità
dell’espressione musicale (il famoso passaggio dal folk al rock che tante
inutili polemiche suscitò a suo tempo), ma di cui si vedrà la profonda
continuità con tutta la sua opera precedente su un tema di fondo: quello
della libertà. Questo infatti è stato il filo conduttore dei primi dischi
e lo sarà anche di tutti i successivi, secondo uno sviluppo che si
identifica con la ricerca di una sempre maggiore autenticità e autonomia,
ma che allo stesso tempo non poté non apparire indizio (e poi prova e
conferma) di disimpegno e superficialità.
Non di questo si tratta ancora in Bringing it All Back Home, il long
playing che costituisce veramente per Dylan un ritorno a casa, un ritorno
verso la sua prima “formazione” nel rock and roll degli anni ’50. Ma
soprattutto un ritorno verso sé stesso come fonte di ispirazione, in cui
esplode, con una ricchezza e un ritmo straordinari, tutta la sua
problematica. La vena lirica giunge a un massimo di sereno equilibrio
(prima di ripiombare nella disillusione), che è indizio, se non del
superamento di una crisi (siano lontani dalla primitiva semplicità di Girl
from the North Country) della maturazione che una complessiva visione
dell’amore comporta. Il filone comico-grottesco compare solo nel 115th
Dream (che ripete l’impianto dei Talking World War III Blues) ed è
comunque intrecciato a complessi riferimenti letterari, in cui ancora una
volta miti americani e miti biblici si fondono in modo assai suggestivo
(l’Acab della canzone è ovviamente un riferimento all’Acab di Melville e
per suo tramite al personaggio biblico).
Il tono generale del disco, non esclusi i due temi di cui sopra, il lirico
e il comico, è quello di una profonda ansia metafisica che in alcuni casi
(come in Gates of Eden) raggiunge dimensioni esplicitamente religiose. Non
dimentico naturalmente che questo è anche il disco della droga. Almeno
così si credette perché quelli erano gli anni della marijuana e dell’LSD
che si cercava di legalizzare, e fu subito detto che il Tambourine Man era
lo spacciatore di droga (senza capire che poteva essere benissimo soltanto
“l’uomo del tamburello” e che per un poeta è molto più importante
l’immagine reale, concreta, di quella metaforica o simbolica), e che tutte
le canzoni erano il frutto di ripetuti trips del cantante. Ma a parte il
fatto che Dylan negò esplicitamente di avere scritto alcuna di quelle
canzoni sotto l’effetto della droga (negli USA non è reato fare uso di
marijuana e di droghe leggere e non avrebbe quindi avuto difficoltà ad
ammetterlo), distinguendo fra scrivere sotto l’effetto della droga e
scrivere di visioni avute sotto la droga (una vecchia storia fin dal tempo
di S.T. Coleridge o di Thomas de Quincy), la questione è senz’altro
irrilevante. Il Dylan di questi versi già in parte lo conosciamo (anche se
mai ne aveva scritti di così belli); i temi trattati sono gli stessi di
sempre, solo sentiti ed espressi con maggiore complessità e finezza di
analisi. Ancora è alla ricerca (in Mr. Tambourine Man) della libertà,
adesso interiore, “lontano dalla portata contorta / del dolore senza
senso”. Ancora una volta ritorna il mare, simbolo di vita e promessa di
felicità.
Yes to dance beneath the diamond sky
With one hand waving free
Silhouetted by the sea
Circled by the circus sands
With all memory and fate
Driven deep beneath the waves
Let me forget about today until tomorrow (31)
Ma è un sogno irrealizzabile. L’oggi è sempre presente con tutta la sua
crudezza e inevitabilità, mentre la liberazione del domani è lontana. Il
mondo fuori dai Cancelli dell’Eden è irrimediabilmente corrotto e la voce
del “passero solitario” (lonesome sparrow) non è che un rantolo nel
frastuono assordante:
While one who sings with his tongue on fire
Gargles in the rat race choir
Bent out of shape from society’s pliers
Cares not to come up any higher
But rather get you down in the hole
That he’s in (32)
Il cupo pessimismo di queste bellissime canzoni sta proprio in questo:
nella perdita dell’entusiasmo missionario e impegnato di Blowing in the
wind o di The times they are a-changing. Adesso che ha raggiunto dentro sé
stesso e scoperto come la malvagità esteriore abbia le sue cause in una
complessa realtà interiore, il poeta sente tutta la futilità delle sue
accuse e delle sue esortazioni. Sente soltanto pietà per chi non riesce a
liberarsi:
But I mean no harm nor put fault
On anyone that lives in a vault
But it’s alright ma if I can please him (33)
Il suo impegno sociale ha compiuto un intero cerchio verso un’accettazione
della realtà di cui non possono sfuggire le ulteriori implicazioni
religiose. Alla porta con i vestiti di un tempo c’è il vagabondo
(hobo-destino-morte-rinascita-sé stesso) che ti chiama. E’ il tempo di
ricominciare tutta da capo: è tutto finito adesso, baby blue.
Così con Highway 61 Revisited Dylan ritorna sulla strada, lascia il
contesto urbano con tutta la immediatezza dei temi che l’attualità gli
aveva suggerito nei precedenti cinque anni -- guerre, razzismo,
ingiustizia, consumismo, alienazione urbana -- e riprende il suo viaggio
nel cuore del grande continente americano (di cui è simbolo appunto la
strada federale 61 che lo attraversa da nord a sud) alla ricerca di quei
miti di cui si nutre la terra e da cui trarre una spiegazione per il
presente. Vi trova un paesaggio desolato, percorso da treni e cosparso di
carcasse di automobili, dove vagano, perennemente inquieti, strani
fantasmi del passato e del presente -- mitici, storici o fantastici -- in
un quadro composito e affascinante, tuttavia molto diverso da quello, pur
efficacissimo, di I Shall Be Free o di altre canzoni del periodo
precedente. Anche là si aveva sensazione di una realtà allucinata, le cui
componenti disposte sullo stesso piano risultavano assolutamente
interscambiabili senza distinzioni categoriali. Ma mentre prima era un
mondo esterno, un affollato panorama di realtà urbana, qui invece ci
troviamo di fronte a un mondo interno, uno spaccato della mente americana
con le sue radici religiose e la sua vocazione alla sradicatezza.
Da queste canzoni saltano fuori a ondate, sul ritmo singhiozzante della
musica, personaggi biblici, ciarlatani, giocatori d’azzardo, banchieri,
fenomeni da baraccone, santoni, zingari, ballerine, venditori ambulanti,
uomini d’affari: miti americani, antichi e moderni, personaggi familiari
all’uomo della strada perché filtrati e ripresentati ciclicamente da tutti
i mezzi di comunicazione di massa, dalla stampa alla televisione e al
cinema, ma anche dalle chiese, dalle scuole, dai riti della politica.
Apparentemente entità svuotate di concreto significato storico-sociale
perché ormai irraggiungibili nella loro perduta realtà storica (o
letteraria): delle icone, quindi, dei meri simulacri di memorie
collettive; ma allo stesso tempo e proprio per questo, nella loro
banalizzazione, perennemente affascinanti perché irraggiungibili;
interessanti non come realtà storiche o letterarie, ma come realtà
psichiche imprescindibili (v. Tombstone Blues, Highway 61 Revisited).
E’ questo il mondo che Dylan vuole adesso farci conoscere, il mondo che
“l’uomo sottile” della ballata non può vedere, perché i fantasmi gli si
agitano nel cervello e lui non sa esorcizzarli perché non ne è neppure
consapevole, e ne rimane schiavo: personaggi spettrali che si agitano
fiammeggianti nel cuore del continente americano, incubi della tecnologia,
vendicatori della vitalità repressa, che ribollono sotto i piedi del “nano
in flanella grigia” (ovvio simbolo di ogni possibile conformismo, come il
Prufrock di Eliot) che con gli occhi nelle tasche è destinato a non capire
cosa sta succedendo:
Well, the sword swallower
He comes up to you and then he kneels
He crosses himself
And then he clicks his high heels
And without further notice
He asks you how it feels, and he says here is your throat back
Thanks for the loan (34)
Creazione altissima, evocazione ed esorcizzazione di questo mondo
fiammeggiante, di questa troppo umana bolgia di demoni terreni è
Desolation Row. Se infatti il paesaggio urbano di questa canzone richiama
alla mente lo squallore dei ghetti urbani d’America (il cui massimo poeta,
prima di Dylan, è stato Allen Ginsberg), il vero soggetto, la realtà qui
descritta, è essenzialmente psichico. Gli sdoppiamenti del reale in
irreale, il passaggio dal concreto al fantastico sono appunto il frutto
dell’esplosione di fantasie erotiche, schizofreniche e paranoiche della
mente americana; una Cenerentola con atteggiamenti da entreneuse, la
purissima Ofelia casta solo per insipienza, pazienti asessuati che
uccidono il loro medico-castratore; uomini condannati a morire sotto il
peso di macchine infernali e altri uccisi lentamente a forza di essere
imboccati.
Questa è la realtà psichica, la terra desolata in cui Dylan adesso abita,
lontano dall’impegno politico, dalla missione profetica e della finzione
letteraria, inaccessibile nel suo cupo pessimismo alla rinfrescante
banalità delle piccole cose quotidiane:
Yes, I received your letter yesterday
About the time the doorknob broke
When you asked me how I was doing
Was that some kind of joke
All these people that you mentioned
Yes I know them, they are quite lame
I had to rearrange their faces
And give them all another name
Right now I can’t read too good
Don’t send me no more letters no
Not unless you mail them from
Desolation row (35)
Questa è la realtà psichica, la terra desolata che T.S. Eliot ed Ezra
Pound, rappresentanti per Dylan di una cultura di élite infinitamente
lontana nel suo classicismo dalla cultura di massa contemporanea, non
conoscono (il riferimento in questi versi alla Lovesong of J. Alfred
Prufrock e al Wasteland di Eliot è del tutto esplicito), impegnati come
sono a combattersi nella cabina di comando e a guardare le loro sirene
intrecciare ghirlande. E’ per questo che i cantanti di calipso (che qui
simboleggiano la vitalità dei primitivi) li deridono:
Everybody’s shouting
Which side are you on
And Ezra Pound and T.S. Eliot
Fighting in the captain’s tower
While calypso singers laugh at them
And fishermen hold flowers
Beetween the windows of the sea
Where lovely mermaids flow
And nobody has to think too much
About desolation row (36)
Qui ovviamente Eliot e Pound sono meri personaggi “letterari” alla stessa
stregua di Cenerentola, Ofelia, il fantasma dell’Opera, Einstein, e di
tanti altri, provvisti quindi di un’esistenza fittizia totalmente slegata
dalla loro realtà storica: sono insomma personaggi kitsch, non guardati
criticamente attraverso lo studio analitico delle loro opere, ma presi
come soggetti delle antologie in cui sono contenuti, dei corsi di poesia
in cui sono letti, delle citazioni sparse casualmente in tutto l’universo
linguistico. Se mai vi è stato (e certo vi è stato) un contenuto
dirompente, dissacrante, nella loro opera, è ormai irrimediabilmente
perduto dopo il passaggio attraverso il tritacarne omogeneizzante della
cultura di massa. Dylan si serve delle loro parole e delle loro immagini
come simbolo di una certa letteratura, anzi della letteratura (non importa
quanto pregnante) nella misura in cui essa, filtrata e massificata dal
sistema scolastico e dall’industria culturale, cessa di essere forza
dirompente e diventa essiccata rappresentazione di una realtà umana
infinitamente distante dall’attualità angosciosa del Vicolo della
desolazione.
E’ interessante soffermarsi sul nesso fra la poesia di Dylan e quella di
Eliot. E’ vero che i versi appena citati hanno implicitamente il
significato di una condanna nei confronti della poesia “colta”, legata ai
miti del passato e non alla crudezza della realtà quotidiana. Del resto
questo atteggiamento da enfant terrible, da poeta maledetto contro la
cultura libresca e per la rinascita dell’autenticità dei sentimenti
(meglio: delle sensazioni e delle emozioni) è caratteristico di Dylan e lo
qualifica nei suoi rapporti (positivi e proficui) con la cultura popolare
contemporanea. Tuttavia, i nessi con Eliot sono più ricchi di quanto
emerga da un casuale accostamento. Intanto per la presenza di specifici
echi eliotiani in molti versi del cantante del Minnesota (basterebbero
quelli appena citati), il che farebbe ritenere se non una consuetudine,
almeno una conoscenza dei testi di Eliot, almeno dei più noti; poi, per la
comune preoccupazione nei confronti del sesso, visto “puritanicamente”
come qualcosa di crudo, di rozzo, seppure di fondamentale. A questo amore
carnale e in un certo senso “peccaminoso” (nel senso di minato da un
peccato originale, da una radicale assenza) fa riscontro un lirismo
oggettivo (cioè non sentimentale), fatto di oggetti, di sensazioni, di
gesti, reso drammatico attraverso la tecnica del dialogo e del monologo
con l’amata; il tutto pervaso da un velo di insostenibile mestizia.
Questo atteggiamento nei confronti del sesso, come pure l’ansia di colmare
il vuoto che la cultura moderna ha aperto tra il corpo e la mente
attraverso l’uso del mito e pescando a piene mani nei simboli del passato
-- che è parte non trascurabile della poesia dylaniana -- costituiscono
una componente importante di quella “americanità” che T.S. Eliot
considerava la matrice prima della sua poesia. Se Dylan invece, avvertendo
quella stessa frattura, per lui non mediata dallo storicismo della cultura
europea (o della cultura tout court), non si rivolge alla “tradizione”
(come ha fatto Eliot), ciò naturalmente è dovuto al fatto che non è un
letterato, non ha la tempra dello studioso, fa un altro mestiere da quello
dell’uomo di cultura. E tuttavia nella sua poesia il mito, soprattutto
quello biblico, ha importanza fondamentale. Anche se in maniera diversa,
ciò che accomuna Dylan a Eliot (o a un altro “americanissimo” scrittore
come Mark Twain) è una sorta di visione allucinata, frenetica nel primo,
pacata nel secondo, in cui sotto alla realtà industriale della vita
moderna, si nasconde il fiume torbido e possente della realtà mitica, (il
fiume, appunto, per Twain, la strada per Dylan, il London Bridge –
quell’intersecarsi simbolico di fluire umano e naturale per Eliot), in cui
spiritualità e corporalità aspirano a fondersi e a placarsi.
Vi è poi nel rapporto Dylan-Eliot la comune matrice del simbolismo
europeo, naturalmente con tutte le debite differenze che possono esserci
tra un poeta letterato, indissolubilmente legato alla carta stampata, e un
poeta elettronico, che è essenzialmente, costituzionalmente, un uomo di
spettacolo. Uno dei pochi autori che Dylan ammette di avere letto, lui
così provocatoriamente reticente nei confronti delle sue ascendenze
letterarie, è Rimbaud. Non è certo questa la sede per illustrare cosa
abbia significato il simbolismo (soprattutto Laforgue) per Eliot. Ma al di
là del vezzo letterario di proclamare una comune matrice poetica fin
troppo agevolmente evidenziabile, vi è la considerazione ben più pregnante
che ciò che Eliot avvertiva (e concretava poeticamente) come sintomo della
crisi della sensibilità del ‘900, per Dylan è realtà acquisita, punto di
partenza per nuove esperienze poetiche, che nascono da un contesto che non
è più quello della società degli anni ‘30. Fra Dylan e l’Eliot della
Wasteland vi è una sorta di continuità quale può esservi fra l’inizio e la
fine di un processo. Quella crisi che Eliot fra i primi aveva descritto,
per la sensibilità collettiva di lingua inglese, è diventata realtà
quotidiana per tutti, e Dylan non è altro che il portavoce elettronico,
l’altoparlante che vibra le note stridule e tristi della alienazione
giunta al suo estremo sviluppo.
Quello che i simbolisti avevano avvertito come il crollo del grande sogno
metafisico dell’idealismo romantico (e per questo giustamente vennero
definiti “maledetti” dai contemporanei) diventò, ai primi del ‘900,
oggetto di ricerca teorica e di sperimentazione artistica: la mente
fratturata, isolata nel suo tumultuoso sentire, incalzata da forze
artificiali, strappata al legame ristoratore con la natura. E’ questo il
filone di realtà “culturale” che attraverso Eliot, Joyce, il futurismo, il
surrealismo, porta dal simbolismo tardo-ottocentesco all’America degli
anni ’50 e ’60, l’America di James Dean, delle giacche di cuoio nero,
delle motociclette, dei beat, del rock and roll, della droga e di Bob
Dylan.
In Blonde on Blonde anche quel movimento verso l’esterno (l’esplorazione
del profondo, il viaggio attraverso il continente) rappresentato da
Highway 61 Revisted trova il suo compimento. Il tono di queste canzoni è
ugualmente pessimistico, ma il loro soggetto è adesso il poeta stesso. La
tematica immediata è quella amorosa, ma quasi sempre la donna amata appare
come una finzione, il velo sottile dietro cui si nasconde Dylan con ancora
tutta la vitalità della sua straordinaria giovinezza (è difficile tenere a
mente che parliamo di un giovane che non ha ancora trent’anni!), ma anche
con tutta la sua ansia di assoluto, la sua incertezza e la sua
disperazione. Se di disperazione si tratta, bisogna tuttavia notare che
essa è sempre trattenuta dal freno dell'ironia. E’ questa infatti una
delle funzioni del complesso rapporto musica-parole nelle canzoni di
Dylan: laddove il messaggio è personale e angoscioso, spesso il ritmo si
fa noncurante e scanzonato, la voce impersonale e distaccata. Dopotutto,
pare che Dylan voglia dirci, non si tratta che di canzoni da ascoltare per
trarne piacere, lui vuole soltanto piacere (37); non è certo lui che ci
obbliga, col silenzio della pagina bianca, a meditare sulle sue o sulle
nostre sventure. E non è poca cosa.
Questo per la musica. Ma a leggere le righe e fra le righe, si ha ben
altra impressione. Non solo l’impegno politico collettivo, ma anche quello
libertario individuale, ha qui completato il suo cerchio. Attraverso la
metafora della delusione amorosa c’è tutta la sofferenza e l’amarezza per
avere percorso una strada senza ritorno:
Now the rainman gave me to cures
And he said jump right in
...
And like a fool I mixed them
And it strangles up my mind
And now people just get uglier
And I have no sense of time (38)
La delusione maggiore è per il tragico ripetersi dell’impossibilità di
comunicare e di amare (Obviously Five Believers) e per il male che
inevitabilmente ci facciamo l’un l’altro pur quando ci amiamo: “e poi dopo
dicesti, mentre io ti chiedevo scusa / che mi stavi solo prendendo in giro
/ che non venivi veramente dalla campagna / e io ti dissi mentre tu mi
strappavi gli occhi / che non avevo mai voluto farti del male” (39). C’è
il senso in questa canzone di un destino da cui ormai non si può più
sfuggire:
And here I sit so patiently
Waiting to find out what price
You have to pay to get out of
Going through all these things twice (40)
E c’è anche la consapevolezza di avere completato il cerchio, di avere
percorso ed essere arrivato alla fine di una strada che doveva essere
seguita: è un’epoca che si chiude, un’epoca di passioni e speranze
politiche, di entusiasmi profetici e umani ridimensionati di fronte a una
più profonda e più tragica visione della realtà:
The fiddler he now steps to the road
He writes ev’rything’s been returned
Which was owed
On the back of the fishtruck that loads
While my conscience explodes
The harmonicas play the skeleton keys and the rain
And these visions of johanna are now all
That remains (41)
Ritorna in questi versi il simbolo della strada, ma con un senso di
stanchezza ben diverso dal lontano orgoglioso Restless Farewell del 1963
(solo tre anni sono passati e pare tutto un ciclo vitale). Ancora l’ansia
della strada, “quell’antica maledizione”, l’impossibilità di rimanere; ma
nell’animo adesso resta solo la sofferenza e la disperazione per
l’avvenire:
And your long-time curse hurts,
But what’s worse
Is this pain in here
I can’t stay in here
Ain’t it clear that I just can’t fit (42)
E allora, con rassegnazione religiosa, soltanto una triste invocazione, un
desiderio di pace e di riposo, in questi che sono forse i versi più belli
di un uomo che sente di essere ormai giunto alla fine della strada e che
pure non si può ancora fermare:
Sad-eyed lady of the lowlands
Where the sad-eyed prophets say that no man comes
My warehouse eyes my arabian drums
Should I put them by your gate
Or sad-eyed lady should I wait? (43)
--------------------------------------------------------------------------------
VI Verso la banalizzazione del contenuto
Verso la fine del 1966, qualche mese dopo avere inciso Blonde on Blonde,
il disco che su una nota di profonda rassegnazione e tristezza poneva fine
alla fase profetica della sua poesia, Dylan ebbe un incidente
motociclistico. La degenza fu lunga e la convalescenza durò molto di più
di quanto ci si potesse aspettare. Dylan sparì dalla circolazione, fece
perdere le tracce di sé, non fece più dischi, non partecipò a concerti,
cancellò tutti gli impegni per quasi due anni. Cosa fece in tutto quel
tempo di volontaria reclusione, dopo la frenetica attività degli anni
precedenti? A un giornalista (Michael Iachetta) che dopo mesi di ricerche
era riuscito a scovarlo nel suo nascondiglio di montagna, Dylan dichiarò:
Ho visto soltanto qualche amico intimo, ho letto un po’ di cose sul mondo
là fuori, ho studiato libri di gente che lei non ha mai sentito nominare,
ho riflettuto su dove sto andando e perché sto sempre correndo, se sono
troppo inguaiato, che cosa posso dire di sapere, che cosa faccio per gli
altri e che cosa ricevo dagli altri. Ma soprattutto ho lavorato cercando
di diventare migliore e di fare della musica migliore, che è la cosa
principale della mia vita. (44)
Quando per la prima volta riapparve in pubblico, nel gennaio del 1968, al
concerto in onore di Woody Guthrie morto da poco, Dylan era indubbiamente
cambiato, al punto che chi lo vide, stentò a riconoscerlo in mezzo agli
altri grandi della canzone folk intervenuti per commemorare Woody, il
maestro di loro tutti. Non solo era cambiata la voce, più dolce, più
melodica, ma tutta la persona dava adesso un’impressione di calma e
serenità.
Contemporaneamente era uscito John Wesley Harding, il primo disco dopo
l’incidente che, confermando le prime impressioni, aveva svelato al grande
pubblico un Dylan ancora una volta completamente diverso: un uomo sereno e
in pace con il mondo, ben diverso dal personaggio tormentato che due anni
prima aveva inciso Blonde on Blonde. Cos’era successo? Solo con
riluttanza, nascondendo più di quanto non svelasse, più di un anno dopo
Dylan accennò a una spiegazione:
Non capii l’importanza di quell’incidente fino almeno a un anno dopo.
Allora mi resi conto che era stato un vero incidente. Pensavo che a un
certo punto mi sarei alzato e mi sarei rimesso a fare quello che facevo
prima… ma non potevo più… E’ difficile parlare di quali cambiamenti ci
siano stati. Non sono cambiamenti che uno può spiegare a parole… oltre ai
cambiamenti fisici…. Non ne voglio parlare. (45)
“A quel tempo – disse altrove – andavo a una velocità terribile,
l’incidente mi costrinse a fermarmi”. E tutto sommato, nonostante il collo
rotto e le costole spezzate, fu un bene perché a quella velocità – il
successo, il tormento, i cambiamenti, la creatività frenetica di sei
incredibili anni -- Dylan non sarebbe andato avanti per molto. Quello che
era cambiato, nel profondo, era il suo atteggiamento nei confronti delle
sue canzoni e nei confronti della vita:
Quello che adesso faccio è mettermi fuori delle canzoni; non sono più
dentro le mie canzoni. Io sono là fuori e le canto semplicemente e non
sono connesso con loro in prima persona. Adesso le scrivo in tempi diversi
di quando le incido. Adesso ho abbastanza tempo per scrivere la canzone
senza pensare di esserci dentro. La scrivo come se dovesse essere qualche
altro a cantarla, poi la faccio – come una copia. (46)
Questo distacco fra l’artista e la sua creazione, concepita adesso non più
come espressione “privilegiata”, individuale, ma come copia di un dentro
intrinsecamente inesprimibile, sarà progressivamente e sempre più
accentuato nei dischi successivi dall’uso di sofisticate tecniche
musicali, impiegando solisti autonomi per la parte musicale e anche per
quella vocale, reinterpretando più volte e in modo diverso la stessa
canzone. Ma soprattutto il distacco nei confronti del prodotto artistico
(che è, appunto, un “prodotto”) è reso possibile da una rivalutazione del
ruolo dall’artista nel mondo, e quindi di se stesso. Non solo Dylan ha
cessato di fare il profeta, ma è anche (almeno apparentemente) guarito
dall’angoscia che gli derivava dall’essere stato profeta di sventure.
Adesso crede in un qualche ordine o equilibrio al di sopra delle
ingiustizie e degli squilibri sociali:
Io faccio della musica; scrivo canzoni, ho un certo equilibrio a proposito
delle cose, e credo debba esserci un ordine per ogni cosa. Sotto a tutto
quanto. Credo anche che ci sia gente il cui compito è di fare il lavoro
di… “guida dei giovani”. Voglio dire che deve pure esserci qualcuno in
grado di fare quel tipo di lavoro. Quanto a me, sono soltanto una persona
e faccio quello che faccio. Cerco di andare d’accordo… di non dare
fastidio alla gente; tutto lì. (47)
Per capire come una trasformazione così radicale possa essersi verificata
nell’atteggiamento di Dylan verso il mondo, bisogna ricordare che essa
risale al 1968, anno che segnò (e non solo per Dylan e per l’America) un
punto di rottura. In America fu l’anno in cui dopo la Convenzione
democratica di Chicago e la violentissima repressione della protesta
giovanile, molte speranze crollarono. La guerra del Vietnam, nonostante la
crescita della protesta pacifista, perfino da parte degli ex soldati (i
veterans against the war), nonostante le promesse elettorali del nuovo
presidente Nixon, continuava a macinare morti ed orrori: era una guerra
“che non finisce mai di finire” (48). Il movimento di protesta si divide
in due: una parte decise di abbandonare i metodi pacifisti e della non
violenza e di radicalizzare la lotta, un’altra, molto più ampia, si ritirò
dalla scena politica, amareggiata e delusa, alla ricerca dell’evasione
nell’esperienza comunitaria, nella droga, nel misticismo, nella filosofia
Zen. Dylan scelse questa seconda strada; già nel 1964 si era allontanato
dal movimento per i diritti civili, adesso lascia ogni forma di impegno
sociale. Non vuole più essere un profeta. Ascoltato da milioni e seguito
da pochissimi nel suo invito alla liberazione interiore, deve avere capito
che qualsiasi cosa dicesse non contava perché il sistema mediatico non
permetteva che contasse: creato dai mass media, Bob Dylan è stato tacitato
da essi. E’, per altri versi, la stessa situazione dello scrittore,
dell’intellettuale americano, così come l’aveva già descritta nel 1930
Sinclair Lewis:
Ci pagano in effetti persino troppo bene. Deve considerarsi un fallimento
quello scrittore che non ha la sua automobile di proprietà, il suo
maggiordomo e la sua villa a Palm Beach, dove può conversare quasi alla
pari con i magnati dell’alta finanza. Ma egli è perennemente oppresso da
qualcosa di peggiore della povertà – dalla sensazione che ciò che egli
crea non conta, che i suoi lettori si attendono da lui che sia soltanto un
oggetto di decorazione o un buffone, che è accettato di buona grazia come
un brontolone che abbaia ma non morde e che probabilmente è un buon
diavolo dopo tutto, e soprattutto certamente non conta un bel niente….
(49)
Forse la più radicale autocritica che Dylan si è fatto è contenuta in una
delle canzoni di John Wesley Harding, in cui si parla di un malvagio
messaggero che aveva una “mente che ingrandiva le cose più piccole”; un
giorno si recò davanti ad un’assemblea e fece a tutti questo catastrofico
annuncio:
The soles of my feet
I swear they’re burning (50)
E’ così che Dylan adesso concepisce il suo passato ruolo di profeta, la
cui voce altisonante considera ora assolutamente sproporzionata al
messaggio di commiserazione personale (e non importa che così non fosse;
questo è quanto Dylan crede di se stesso adesso). Ma a quell’annuncio
l’assemblea, stanca del farneticare del messaggero, rispose con parole
semplici:
Which opened up his heart
If you cannot bring good news
Then don’t bring any (51)
Anche altre canzoni del disco si inseriscono in questa atmosfera di velato
simbolismo autobiografico. As I Went out One Morning pare richiamare,
criticamente, il periodo della protesta politica. Drifter’s Escape
potrebbe essere l’immaginosa reminiscenza della liberazione dai falsi
tribunali della morale. Non è privo di significato, comunque, che
riappaiano, per la prima volta dopo molti anni, in questo disco due
canzoni d’amore che per freschezza e semplicità ricordano i sentimenti
adolescenziali dei primissimi dischi: Down Along the Cove e I’ll Be Your
Baby Tonight. E anche se in seguito questa semplicità scivolerà spesso
nella banalità, qui soprattutto, dopo le angosce dei dischi passati,
questi versi hanno tutto il sapore di una freschezza di vedere e di
sentire da lungo tempo dimenticata:
Shut the light shut the shade
You don’t have to be afraid
I’ll be your baby tonight (52)
...
Down along the cove
We walked together hand in hand
Everybody watching us go by
Knows we’re in love and they understand (53)
Anche le altre canzoni, pure popolate dai consueti strani personaggi
dell’immaginario dylaniano -- ladri, giocolieri, immigrati, banditi,
santi, hobos -- non hanno più il carattere fiammeggiante di un tempo e si
situano a un livello simbolico altamente rarefatto. La smaliziata
conoscenza di tutta la gamma di valori attribuibili agli “oggetti” poetici
(musicali, come verbali), di cui Dylan aveva dato ampia prova in passato,
permette adesso al cantante, libero da ingombranti contenuti emotivi, di
costruire forme quasi astratte, i cui colori sfumati hanno
l’inconfondibile aspetto del kitsch d’arte. (54)
Questo carattere di “riproduzione”, di copia contrapposta ad un originale
irraggiungibile, se forse non è avvertito pienamente in canzoni complesse
e dense come The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest o I Dreamed I Saw
Saint Augustine, diventerà sempre più evidente nei dischi successivi, più
astratti, idealizzanti, bucolici.
Anche il messaggio sociale o latamente politico, seppure qua e là ancora
presente, non ha più i toni dell’infuocata denuncia, ma del blando
ammonimento con fare distaccato e conciliante. Si vede proprio che Dylan
cerca adesso “di andare d’accordo”. E se da un lato questo è l’indubbio
segno del suo disimpegno politico e del suo disinteresse sociale
(confermato da lui stesso in varie interviste di quegli anni), dall’altro
è anche il primo passo verso la conclusiva accettazione della realtà in
termini strettamente religiosi (con successive conversioni prima al
giudaismo e poi al cattolicesimo).
Con Nashville Skyline, uscito nel 1969, pare realizzarsi in pieno una
frase di Dylan già citata: “la musica è la cosa principale della mia
vita”, almeno nel senso in cui musica vuol dire assenza di messaggi
verbali. Se Dylan si rifiuta adesso di pronunciare parole pregnanti di
emotività, forse è per mettere in pratica l’ammonimento che l’assemblea
aveva fatto al messaggero malvagio: “se non puoi portare buone notizie /
allora non portarne alcuna”. E non avendo alcuna buona notizia da riferire
(perché almeno questo dobbiamo concedere a Dylan nel suo disimpegno: certo
non si illudeva che il mondo fosse diventato migliore semplicemente perché
lui aveva smesso di protestare), eccetto la propria individualissima gioia
ritrovata, si limita a recitare, anzi a balbettare, parole di amore:
“Peggy Day mi ha rubato il cuore / perbacco che altro posso dire / eccetto
che la notte con lei vorrei passare” (55). Per lo stesso motivo adesso si
interessa a varie tecniche di produzione musicale: recupera la melodia,
prova la voce pastosa, l’effetto eco, lo sdoppiamento della voce, il
missaggio elettronico; tutte cose che avrebbe considerato anatema ai tempi
di The Freewheelin’ Bob Dylan. I suoi passati dischi folk gli sembrano
adesso bidimensionali, piatti; sostiene che “oggigiorno non c’è più motivo
di fare dischi così”. (56)
A confermare questa nuova concezione del rapporto musica-parole la prima
canzone di Nashville Skyline è una nuova Girl from the North Country, una
canzone che gli era molto cara (come ebbe a dichiarare), presentata adesso
in una versione melodica, banale, stereotipata. L’azione dissacrante nei
confronti di una lirica un tempo così intensamente vissuta (ma la stessa
operazione la farà anche con la mitica Blowing in the Wind, che per adesso
si rifiuta di cantare e quando la canterà farà piangere – di rabbia – i
suoi fans) consiste appunto nella negazione del suo significato, nella
distruzione del suo valore emotivo personale.
Cosa pensare allora di questa e delle altre canzoni d’amore del disco,
dolciastre, carnevalesche, a volte anche grossolanamente sboccate? Esse
sono innanzi tutto il sintomo e la prova della crisi creativa di Dylan tra
il ’68 e l’inizio degli anni ‘70; crisi che, quando tutto è detto, rimane
un fatto inoppugnabile. Sono poi probabilmente l’espressione di un
autentico, se limitato, sentimento di serenità e di liberazione, che a
volte presenta tratti di un’ingenuità sconcertante. Sono, nella
intenzionale povertà di significati, così stridente rispetto al passato,
testimonianze di questa successiva fase della poetica di Dylan,
interessato principalmente alla musica. Ma sono anche, ed è questo
l’aspetto più interessante e meno facilmente decifrabile, complessi
oggetti culturali dotati di una fitta rete di implicazioni.
Per noi infatti queste canzoni hanno un qualche interesse verbale proprio
perché provengono da un artista di cui conosciamo l’abilità e l’intensità
della tecnica espressiva. La banalità di queste canzoni è quindi sospetta
e non può essere presa allo stato elementare del fatto. Se messe in
relazione con la precedente produzione di Dylan, esse ci appaiono come una
barriera di non significazione, dietro la quale può recedere indisturbato,
e finalmente protetto nella sua intimità, l’autore. Ma proprio perché non
sono espressione di lui (dei suoi sentimenti e valori di adesso) esse
acquistano allo stesso tempo una loro autonomia, magica e irraggiungibile:
perché adesso le assonanze, le alliterazioni, i giochi di parole più
semplici sono fini a sé stessi e non sono lo strumento per esprimere stati
d’animo esterni alla loro realtà verbale. La rivalutazione del semplice,
del banale, a cui assistiamo è l’ultima possibilità di utilizzare le
parole, quando tutto è stato detto e quando si è ormai stanchi “di tutto
questo ripetersi (57)”: allora le forme più elementari assumeranno per la
loro apparente immediatezza un valore incantatorio, come una primitiva
visione infantile.
Lo stesso discorso vale per Self-Portrait dove, la maggior parte delle
canzoni non sono neppure di Dylan, mentre le altre sono composizioni o
interpretazioni del tipo appena indicato. In alcune di esse si avverte
perfino il gusto del gesto provocatorio: chi mai avrebbe immaginato
qualche anno fa che Dylan avrebbe finito col cantare canzoni non sue e,
fra le tante, proprio un prodotto così consunto dall’uso e privo di
qualsiasi significato (anche se è una bellissima canzone) come Blue Moon?
Vi è indubbiamente da parte di Dylan il consapevole abbandono della parola
pregnante e la scoperta della banalità, di cui evidentemente – strategie
della comunicazione a parte – avverte ora anche il fascino acquietante.
Ma, allo stesso tempo, questa accettazione della banalità, questa fuga
nella vacuità, è per un artista attento come Dylan l’inevitabile
conseguenza dell’avere avvertito (e con quanta sofferenza!) la
vanificazione del contenuto operata dal riverberare costante del mezzo di
comunicazione (o, se vogliamo, dallo star system).
Viene così concretamente verificata la tesi che enunciavo nella prima
parte di questo lavoro come possibile chiave interpretativa dello sviluppo
stilistico di Dylan, in risposta a quanti lo criticavano per il suo
“tradimento” o lo compativano per la sua perdita di “creatività”. In
realtà Dylan, con le sue contorsioni e cambiamenti radicali, è sempre
rimasto se stesso e, da insuperato escape artist, è riuscito a spiazzare
(non una o due, ma mille volte!) il suo pubblico. E allora,
l’accettazione, la propugnazione della banalità, non come crisi o
tradimento, ma come inevitabile conseguenza dell’avere avvertito la
vanificazione del valore semantico oggettivamente operata
dall’introduzione del messaggio sulla rete dei mezzi di comunicazione di
massa. Il velleitario cantante folk di una inesistente civiltà contadina
si è trasformato, nel corso di una travagliata carriera, nell’autentica
espressione (canora) del nostro mondo elettronico. E se questo implica un
impoverimento di contenuti, sarà triste, ma tristemente vero, e forse
anche necessario. Quando parlare, o meglio comunicare, è impossibile,
allora tacere per non ingannare diventa una necessità. Ma lui è un
menestrello e la musica l’ha salvato dal silenzio.
Rimane comunque il fatto che, anche se ingegnose, queste di Dylan non sono
che manipolazioni di valori contenutistici rese possibili dall’attuale
mercato degli oggetti culturali, così come è stato trasformato dai mass
media. Dylan può anche divertirsi a stampare le sue copie di copie di
farfalle finte e lasciare che l’ascoltatore le faccia volare per tutto il
tempo che ne avrà voglia (perché adesso il valore della canzone non è
nella sua intrinseca espressività, ma dipende esclusivamente
dall’ascoltare collettivo, il pubblico concepito non come ricettore di
messaggi, ma come mercato). Finisce però che anche questi oggetti
privilegiati, determinati non da alcuna caratteristica semantica interna,
si esauriscono – salvo provvidenziali effetti ottici – nel movimento
psicologico necessario a tracciarne la mappa. Ginnastica che può anche
essere divertente, ma che presto diventa stancante (eseguita una volta,
poi ne vale più la pena?), come stanca ormai certa narrativa o certa
grafica e cinematografia d’avanguardia che si risolve tutta nella propria
ellitticità.
Quanto di Dylan, consapevole o inconsapevole, vi sia nelle precedenti
osservazioni è impossibile dirlo perché non ci sono sue testimonianze
esplicite. Quello che però in lui in questo periodo è certamente esplicita
è la consapevolezza della propria sterilità, della propria interiore
inadeguatezza. Self-Portrait inizia con una canzone costituita dal solo
distico:
All the tired horses in the sun
How am I supponed to get any riding done (58)
ripetuto 14 volte da un leggiadro coretto femminile con varianti di
violini nell’accompagnamento. A questa confessione Dylan aggiunge in altre
canzoni una promessa per il futuro, venata da un tocco della sua abituale
autocommiserazione. Il “minstrel boy” (della canzone omonima) è ancora
sulla collina e non ha mai smesso di fare il suo spettacolo; è solo e
stanco, ha lavorato duro, i sogni gli agitano il cervello, eppure:
With all of his travelling
I am still on that road (59)
Lo stesso senso di implicita promessa è adombrato in The Mighty Quinn,
personaggio di eschimese fantastico il cui arrivo sistemerà ogni cosa: gli
infelici saranno contenti, gli insonni potranno dormire, perfino i
piccioni voleranno a lui. Non ha importanza tanto sapere chi sia Quinn,
quanto rilevare che il personaggio, nel contesto esuberante della canzone,
è simbolo di vitalità, di speranza in una rigenerazione che ancora deve
venire.
Da queste posizioni il salto è breve. Non c’è quindi da stupirsi che a
Self-Portrait faccia seguito New Morning, il nuovo mattino la cui novità
fondamentale consiste nell’aperta professione di fede di Father of Night,
efficace rifacimento di un salmo biblico, e di Three Angels, in cui Dylan
lamenta la cecità degli uomini che non sanno vedere i messaggeri divini.
Ammontano anche ad una professione di fede, questa volta nell’amore, un
gruppetto di canzoni (fra cui le migliori sono Time Passes Slowly e If
Dogs Run Free) in cui Dylan canta le delizie e la forza rigeneratrice del
suo amore campestre.
Lo scenario è completamente diverso da quello cui eravamo abituati: non è
più la desolata campagna, fatta di miseria e razzismo, dove si annida la
follia e la furia omicida. Adesso davanti a noi c’è un paesaggio
stereotipato fatto di ruscelli limpidi, di boschetti ombrosi e di valli
verdi; luminoso e sereno, contemplato con quello strano senso di distacco,
che è proprio dei convalescenti, e con quella trepida esitazione che è
propria dei bambini. Sentiamo che il poeta è placato, se non proprio
tranquillo. La ribollente carica di energia, che riverberava nei suoi
dischi fino a tutto Blonde on Blonde come un fiume impetuoso e
incontrollabile, è ridotta a un rivolo che scorre dolcemente,
elegantemente condotto sul filo di musichette leggere che fanno pensare ai
vestitini di carta delle bambole. Il profeta che con i piedi in fiamme
percorreva le strade del buio continente americano gettando una luce cupa
sui suoi angoli più risposti e più squallidi, adesso cammina su sentieri
di verde in un qualche paradiso terrestre che noi non conosciamo. Lo
ritroviamo seduto fra gli alberi: guarda, gioca, crede, ama, sente
finalmente (anche se con qualche dubbio residuo) che la felicità è fatta
di cose semplici: una casa, una moglie, “un mucchio di bambini”. (60)
Placato, ma non proprio tranquillo: non siamo ancora dentro i cancelli
dell’Eden. L’ “antica maledizione fa ancora male”, gli incubi di un tempo,
anche se in forma più blanda e in parte esorcizzati, ritornano. Day of the
Locusts, oltre ad avere un preciso riferimento autobiografico (la consegna
della laurea ad honorem da parte dell’Università di Princeton), ci riporta
nell’atmosfera allucinata della Ballad of a Thin Man e di tante altre
canzoni degli anni passati. Ma adesso il poeta ha imparato che non è
lecito indugiare su tali immagini e che bisogna fuggire verso la serenità:
I put down my robe
I picked up my diploma
Took a hold of my sweetheart
And away we did drive
Straight for the hills
The black hills of Dakota. (61)
Segno di una ritornante incertezza di un oscuro presagio è invece la
canzone Went to See the Gypsy, costruita come uno di quei sogni in cui gli
oggetti reali ci appaiono combinati in modo irreale senza che noi stessi
ce ne rendiamo conto, traendone solo un senso di disagio e di
inquietudine. Il carattere specifico di questo, rispetto agli altri sogni
fantastici di Dylan, sta in un diverso senso del tempo e del movimento,
più lento e silenzioso, e nell’emozione più contenuta. L’incontro con lo
zingaro (come già quello con la ragazza zingara di Spanish Harlem
Incident) ha il significato di una verifica del poeta di fronte ai miti in
cui egli si identificava e che lo zingaro compendia: il ciarlatano, il
santone, l’acrobata, il pagliaccio, il vagabondo; uomini che hanno tutte
le risposte e che conoscono il destino. Allo zingaro il poeta pone le
domande di sempre e da lui, come sempre, aspetta una risposta ed un senso.
La stanza è buia e ingombra di tutti gli oggetti di un passato tumultuoso;
distratto da una telefonata, il poeta si allontana per scoprire al suo
ritorno che lo zingaro l’ha abbandonato: “trovai una stanza spalancata /
ma lo zingaro non c’era più / e quella graziosa ballerina / anche lei era
sparita”. La notte è finita e il poeta è di nuovo solo di fronte a tutte
le sue domande inespresse senza risposta:
But the dark does die
As the curtain is drawn
And somebody’s eyes
Must meet the dawn (62)
E’ così con un indicibile senso di tristezza e con tutto il dolore di una
mancanza incolmabile che Dylan guarda adesso, da quella finestra rigata di
lacrime, sorgere il sole di questo ambiguo, piovoso Nuovo Mattino.
--------------------------------------------------------------------------------
VII. “Still on that Road”
Sarebbe fin troppo facile a questo punto rilevare alcuni vistosi paralleli
fra quest’ultima (in ordine di tempo) fase poetica del cantante e la sua
vita più propriamente politica. Probabilmente non è un caso che mentre
Dylan, questo decadente degli anni ’70 nel suo “buen retiro” di Woodstock,
esaltava le gioie della vita all’aria aperta, i suoi abili amministratori
newyorkesi comperavano immobili, pacchetti azionari, e case di edizioni
musicali. Né è privo di interesse notare che la riscoperta della propria
religiosità (ebraica) si esprimesse anche attraverso finanziamenti
all’organizzazione sionistica di destra Jewish Defense League. D’altro
canto, il suo ostinato e riprovevole silenzio sui moti universitari
americani ed europei di quegli anni, e soprattutto sulla guerra del
Vietnam, potrebbe difficilmente essere imputato a connivenza con il potere
universitario o con i fabbricanti di armi. Forse Dylan aveva capito che,
una volta diventato ricco, sarebbe stato fin troppo facile continuare a
fare quello che ormai dal 1968 facevano tutti i progressisti d’America
senza alcun risultato (e con dosi sempre crescenti di falsa coscienza):
protestare contro la guerra, la povertà, l’ingiustizia e così via. Se il
suo atteggiamento di disimpegno è senz’altro deprecabile, dobbiamo
tuttavia notare che esso nasceva, almeno consapevolmente, da una precisa
rivalutazione del ruolo della sua arte e delle possibilità (o piuttosto
impossibilità) dirompenti del messaggio artistico nel mondo di oggi: “Io
non credo che le canzoni possano cambiare nessuno”, aveva detto fin dal
1964. (63)
Tutta la problematica di Dylan dopo l’incidente e il senso esplicito del
suo sviluppo sta proprio nel dare seguito a questa convinzione, traendone
tutte le conseguenze, nell’accettare sé stesso come un artista-artigiano,
non al di sopra delle parti, ma non per questo meno futile e inutile alla
concreta lotta politica. D’altro canto, il messaggio libertario del
secondo periodo di Dylan, quello profetico, parte proprio dal presupposto
che per eliminare le guerre e le ingiustizie bisogna prima liberare sé
stessi, riappropriarsi della propria mente, rifiutandosi di seguire le
mode o di appartenere ai movimenti, tagliare insomma tutti i legami che ci
bloccano a un destino non nostro.
L’impegno sociale di Dylan, nella misura minima in cui è ancora presente,
va nella direzione della liberazione individuale e non della lotta
politica. Non si deve quindi pensare che una delle sue ultime canzoni
dedicata alla pantera nera George Jackson, ucciso brutalmente in un
carcere americano nel 1971, rappresenti un ritorno alla politica attiva.
Del militante nero Dylan esalta i tratti umani del carattere, il suo
potere e il suo amore, e non l’importanza della sua azione rivoluzionaria.
I versi dell’ultima strofa:
Sometimes I think this ol’ world
Is one big prison yard
Some of us are prisoners
The rest of us are guards (64)
ci ricordano piuttosto che oggi, nella nostra società tecnologica,
prigionieri e guardie, oppressi e oppressori, siamo tutti condannati
all’ergastolo dentro le stesse mura, anche se gli uni hanno le armi e
uccidono e gli altri sono costretti a subire. Ancora una volta il
messaggio di Dylan è per la liberazione totale (per abbattere le mura e
non per riformare il carcere): “c’è soltanto un modo – aveva detto – per
cambiare le cose, ed è liberarsi da tutte le catene”. (65)
--------------------------------------------------------------------------------
NOTE:
1 Dall’intervista a N. Ephron e S.Edminston, 1965. Questa come altre
interviste cui si fa riferimento nel testo, se non diversamente indicato,
sono pubblicate in Bob Dylan: a retrospective, a cura di Craig Mc Gregor
(New York, 1972).
2 Da un’intervista a Sing Out!, ottobre-novembre 1968.
3 Nella Galassia Gutenberg: Nascita dell’Uomo tipografico (trad. di S.
Rizzo, Armando Armando, Roma 1976).
4 Laterza, Bari, 1967.
5 Ballad of a Thin Man: “Sta succedendo qualcosa / e tu non sai che cos’è
/ vero, Mr. Jones?” (Le traduzioni che compaiono in questo articolo non
sono le stesse, pure dello stesso autore, che compaiono nei due volumi dei
testi delle canzoni di Dylan: Blues, ballate e canzoni e Canzoni di amore
e di protesta, entrambi pubblicati nel 1972 da Newton Compton.)
6 E’ interessante quest’uso di un termine proprio di una forma espressiva
che identifichiamo con il medioevo. Anche McLuhan pensava che il passaggio
dalla modernità tipografica e visiva alla contemporaneità elettronica e
tattile era simile ad una sorta di ritorno al medioevo dei copisti e dei
menestrelli.
7 Da un’intervista a Rolling Stone, novembre 1969.
8 Ora descritti con dovizia di particolari da Howard Sounes nel suo Bob
Dylan (Guanda, Parma 2002).
9 “I gotta go to work” mi disse Dylan molti anni dopo a Roma interrompendo
una nostra chiacchierata nel suo camerino prima di un concerto.
10 Da un’intervista a N. Ephron e S. Edminston, 1965, cit.
L’anno successivo, nell’intervista a Nat Hentoff apparsa su Playboy (marzo
1966), aggiungeva: “E’ molto stancante avere gente che ti dice quanto sei
bravo quando tu stesso non ti piaci… Cantavo un sacco di canzoni che non
volevo cantare.”
11 Dall’articolo sul New York Times del 29 settembre 1961.
12 Talkin’ New York: “Mi tirai il berretto sugli occhi / e presi la strada
dei cieli dell’Ovest.”
13 Song to Woody: “ Un giorno / le ultime parole / che vorrei poter dire /
sono: / anch’io sono stato sulla strada.”
14 Bob Dylan’s Dream: “Con gli occhi umidi guardavo la stanza / dove con i
miei amici avevamo passato tanti pomeriggi / mentre fuori il temporale
infuriava / cantavamo e ridevamo / fino alle prime ore del mattino.”
15 Riportato da C. Izzo nella sua Antologia della poesia americana
1850-1950 (Garzanti 1971), vol. III pag. 226.
16 Che nel suo discorso di accettazione del premio Nobel per la
letteratura, nel 1930, farà considerazioni sorprendentemente analoghe sul
rapporto tra l’intellettuale e la società che lo applaude e lo rende
ricco, e sulla difficoltà, se non impossibilità, di rimanere “autentico”
(cfr. il mio Artista e pubblico nella critica americana degli anni ‘30, La
Biennale di Venezia, 1975).
17 Dall’intervista a Gil Turner, pubblicata su Sing Out!, ottobre-novembre
1962
18 Blowing in the Wind: “Quante volte può un uomo voltare la testa / e
pretendere di non vedere / la risposta, amico mio, soffia nel vento / la
risposta soffia nel vento.”
19 A Hard Rain’s Gonna Fall: “Ho visto diecimila che parlavano / e avevano
le lingue spezzate / …Ho sentito diecimila che bisbigliavano / e nessuno
ascoltava / …Ho sentito la canzone di un poeta / che è morto per la strada
/ ho sentito il suono di un clown / che piangeva nel vicolo / …E lo dirò e
lo proclamerò / e lo penserò e lo respirerò / e lo rifletterò dalle
montagne / così che ogni anima possa vederlo.”
20 Ballad of Hollis Brown: “Ci sono sette morti / in una fattoria del Sud
Dakota / da qualche parte lontano / altri sette sono nati.”
21 Only a Pawn in Their Game: “Dalle baracche della sua miseria / guarda
attraverso le crepe verso la ferrovia / e gli zoccoli gli martellano il
cervello / gli hanno insegnato a camminare nel branco / a sparare nella
schiena / con il pugno contratto / a impiccare e a linciare / a
nascondersi sotto il cappuccio / a uccidere senza dolore / come un cane
alla catena.”
22 One Too Many Mornings: “Quando tutto quello che dico / tu lo puoi dire
altrettanto bene / tu hai ragione dalla tua / e io dalla mia / per
entrambi è passato un mattino di troppo / e siamo mille miglia lontani.”
23 Restless Farewell: “Ma le battaglie sono finite / le abbiamo uccise
tutte / le tavole sono piene e traboccano / e il cartello all’angolo /
dice che è ora di chiudere / così dirò addio e me ne andrò per la mia
strada.”
24 Ibid.: “Ma se la freccia è diritta / e la punta è acuminata / può
penetrare nella polvere / non importa quanto spessa / così mi alzerò in
piedi / e rimarrò come sono / dirò addio e non mi importerà nulla.”
25 Hentoff riferisce il suo colloquio con Dylan in un articolo sul New
Yorker, 24 ottobre 1964, dal titolo “The Crackin’, Shakin’, Breakin’
Sounds”.
26 Hentoff, cit.
27 All I Really Want to Do: “semplificarti classificarti / negarti
sfidarti o crocifiggerti / tutto quello che voglio /
è esserti amico.”
28 It Ain’t Me Babe: “Vattene dalla mia finestra /vattene più presto che
puoi / io non sono quello che tu vuoi / non sono quello di cui hai
bisogno.”
29 I Shall Be Free n. 10: “Mi farò crescere i capelli fino ai piedi / così
strani / che sembrerò una montagna che cammina / poi cavalcherò dentro
Omaha / andrò al country club e sui campi da golf / con il New York Times
sotto il braccio / tirerò qualche buca / gli farò esplodere la mente.”
30 Spanish Harlem Incident: “Sono senza casa, vieni e portami / nel
cerchio vibrante dei tuoi tamburi / Fammi conoscere il mio futuro / qui
sulle mie palme inquiete / … Fammi sapere, debbo saperlo / se sei tu che
la linea della mia vita indica / … Mi sono spesso interrogato / fin da
quando ti ho visto laggiù / … Debbo saperlo, ti potrò toccare / così da
sapere se sono veramente vero.”
31 Mr. Tambourine Man: “Sì, danzare sotto un cielo di diamante / con una
mano che ondeggia libera / stagliato contro il mare / circondato dalle
sabbie del circo / con la memoria e il destino / sepolti sotto le onde /
fammi dimenticare l’oggi fino a domani.”
32 It’s Alright Ma (I’m Only Bleeding): “Mentre uno che canta con la
lingua in fiamme / rantola nel coro della corsa dei topi / deformato dalle
tenaglie della società / non gli importa nulla di salire più in alto / ma
piuttosto di farti sprofondare nel buco / in cui si trova.”
33 Ibid.: “Ma non voglio far del male e neppure incolpare / chiunque viva
nella sua volta sotterranea / ma va bene così se posso divertirlo:”
34 Ballad of a Thin Man: “Be’, il mangiatore di spade / ti si avvicina e
si inginocchia / si fa il segno della croce / e poi scatta sull’attenti. /
Ti chiede come ti senti e se ti hanno restituito la gola / grazie per il
prestito.”
35 Desolation Row: “Sì, ho ricevuto la tua lettera ieri / dove mi dici di
quella volta che si è rotta la maniglia / quando mi hai chiesto come me la
passavo / voleva essere una battuta? / Tutta questa gente di cui parli /
sì, li conosco, non mi dicono nulla / ho dovuto rimescolare le loro faccie
/ e dare loro un altro nome / Adesso non riesco a leggere tanto bene / non
mandarmi più altre lettere / no, a meno che non le spedisci / dal vicolo
della desolazione.”
36 Ibid.: “Tutti gridano / da che parte stai / e Ezra Pound e T.S. Eliot /
si prendono a pugni nella torre di comando / mentre cantanti di calipso
gli ridono dietro / e i pescatori mostrano mazzi di fiori / tra le
finestre del mare / dove nuotano graziose sirene / e nessuno deve
preoccuparsi troppo / del vicolo della desolazione.”
37 Nel corso della sua carriera D. è sempre rimasto attaccato ad un
valore: il lavoro. Il suo è di essere un cantante, un menestrello, che
intrattiene il suo pubblico. Che cosa il pubblico faccia o pensi delle sue
canzoni, non è affar suo; lui non è un leader politico, non è un
portavoce. La sua recita finisce sulla scena quando si spengono le luci. A
questo ideale, conquistato con grande sofferenza personale e attraverso
inaudite polemiche, è rimasto cocciutamente legato, non deflettendo mai,
vietandosi qualsiasi gesto di divismo. Una “scontrosità” che è
strettamente legata, come vedremo in seguito, al suo bisogno di
autenticità.
38 Memphis Blues Again: “L’uomo della pioggia mi ha dato due cure / e mi
ha detto, dai, unisciti a noi / … E io come uno stupido le ho mischiate /
e adesso mi sento la mente soffocare / la gente diventa sempre più brutta
/ e ho perso il senso del tempo.”
39 One of Us Must Know.
40 Memphis Blues Again: “E sono qui seduto con tanta pazienza / e aspetto
di sapere qual è il prezzo / da pagare per smettere / di ripetere tutte
queste cose due volte.”
41 Visions of Johanna: “Il violinista adesso scende in strada / e scrive
che ogni cosa è stata restituita / che era dovuta / sul dietro del camion
del pesce che stanno caricando / mentre la mia coscienza esplode / le
armoniche suonano tasti scheletrici e la pioggia / e queste visioni di
Johanna sono tutto quello rimane.”
42 Just Like a Woman: “E la tua antica maledizione fa male / ma quello che
è peggio / è il dolore che provo qui dentro / non ce la faccio più a
rimanere qui / non capisci che non è il mio posto?”
43 Sad-Eyed Lady of the Lowlands: “Triste signora delle vallate / dove i
profeti dagli occhi tristi dicono nessun uomo è mai giunto / i miei occhi
di magazzino i miei tamburi arabi / li potrò lasciare alla tua porta /
o, mia signora, dovrò ancora aspettare?”
44 L’intervista fu pubblicata sul Daily News di New York, l’8 maggio 1967.
45 Dall’intervista a Jann Wenner, Rolling Stone, 29 novembre 1969.
46 Da una conversazione fra Dylan e John Cohen e Happy Traum, riprodotta
su Sing Out!, ottobre–novembre 1968; cfr. anche l’intervista a John Landau
per Crawdaddy, 1968.
47 Dall’intervista a Jann Wenner, cit.
48 Come disse Daniel Ellsberg, il ricercatore della Rand Corporation che
passò i Documenti del Pentagono sulla guerra al New York Times.
49 Nel già ricordato “The American Fear of Literature”, discorso di
accettazione del Premio Nobel per la letteratura, 1930.
50 The Wicked Messenger: “Le piante dei miei piedi / giuro che stanno
bruciando”.
51 Ibid.: “che gli aprirono il cuore / se non puoi portare buone notizie /
non ne portare nessuna.”
52 I’ll Be Your Baby Tonight: “spegni la luce, chiudi le tende / non aver
paura / stanotte sarò il tuo bambino.”
53 Down Along the Cove: “giù nella piccola valle / camminammo mano nella
mano / tutti ci guardavano passare / sapevano che ci amiamo e capivano.”
54 Secondo una delle definizioni di Abraham Moles: Kitsch ou l’art du
bonheur (Parigi, 1971).
55 Peggy Day.
56 Cito ancora dall’intervista a Jann Wenner.
57 Queen Jane Approximately.
58 Self-Portrait: “Tutti i cavalli stanchi al sole / come farò ancora a
cavalcare?”
59 Minstrel Boy: “Con tutto il suo viaggiare / sono ancora su quella
strada.”
60 Sign on the Window.
61 Day of the Locusts: “Mi tolsi la toga / e presi il mio diploma /
afferrai la mia ragazza / e ce ne andammo via / diritti verso le colline /
le nere colline del Dakota.”
62 Restless Farewell: “Ma il buio muore / quando la tenda viene tirata / e
gli occhi di qualcuno / dovranno incontrare l’alba.”
63 In un intervista a Nat Hentoff, “The Crackin’, Shakin’, Breakin’
Sounds”, New Yorker, 24 ottobre 1964.
64 George Jackson: “Qualche volta penso che questo vecchio mondo / è come
il cortile di una grande prigione / alcuni di noi sono prigionieri / altri
sono le guardie.”
65 Nell’intervista a N. Hentoff, cit.
--------------------------------------------------------------------------------
L'autore: Stefano Rizzo, torinese, ha vissuto a New York. E' oggi
consigliere della Camera dei Deputati. Autore tra l'altro di saggi su
letteratura italiana e americana e su problemi di comunicazione. Ha
pubblicato la raccolta di racconti "Variazioni" (Rubettino, 1998) e
"Mohammed" (Mesogea, 2003 - Vedi box in fondo a questa pagina). Nel 1972
tradusse i testi di Bob Dylan nel volume "Bob Dylan - Blues, ballate e
canzoni" (Newton Compton). Da ricordare anche il volume, sempre del 1972,
"Canzoni d'amore e di protesta".